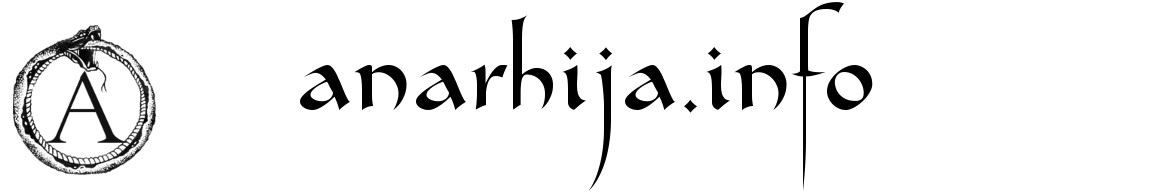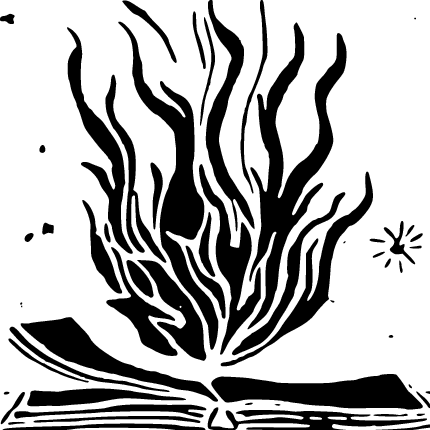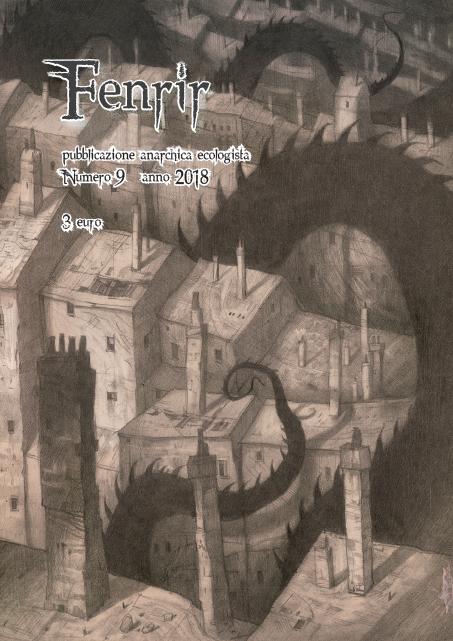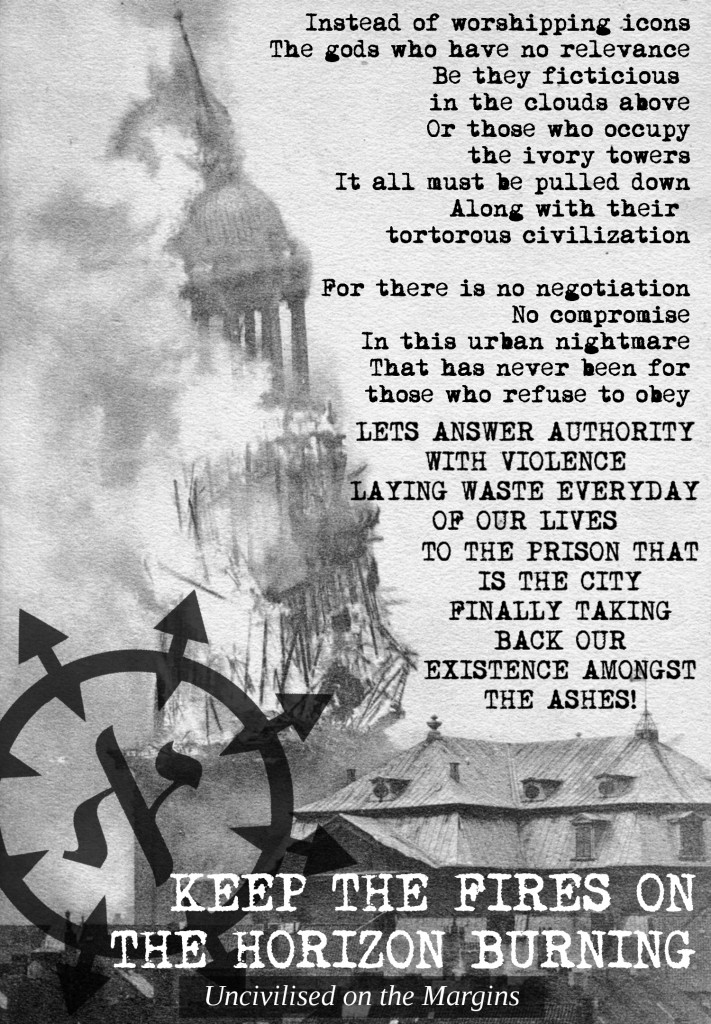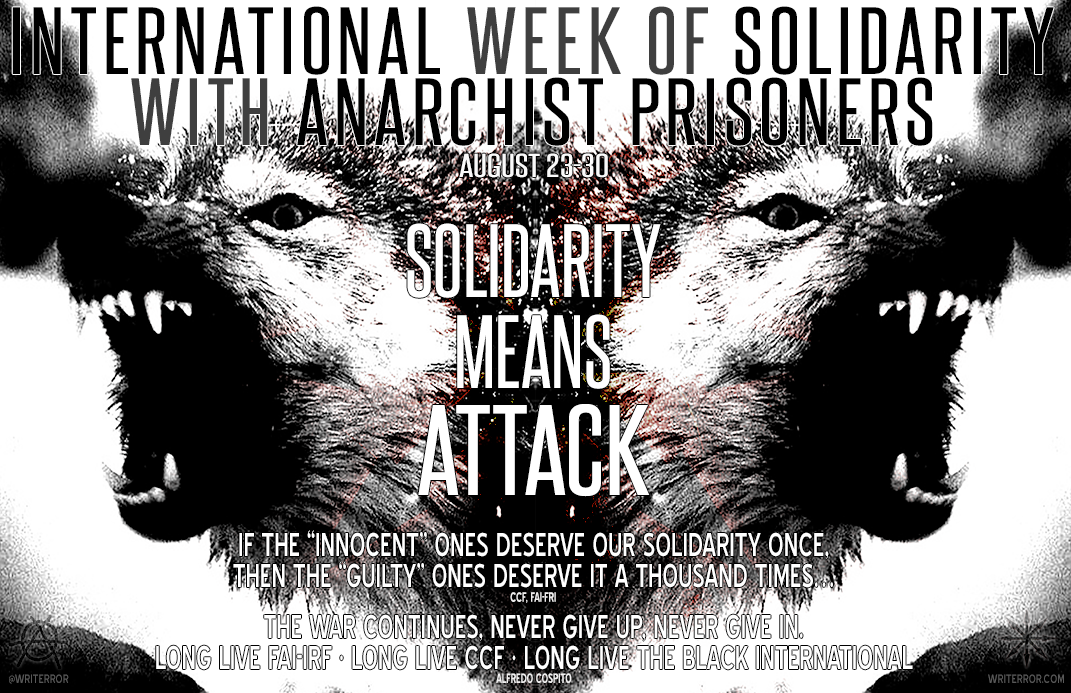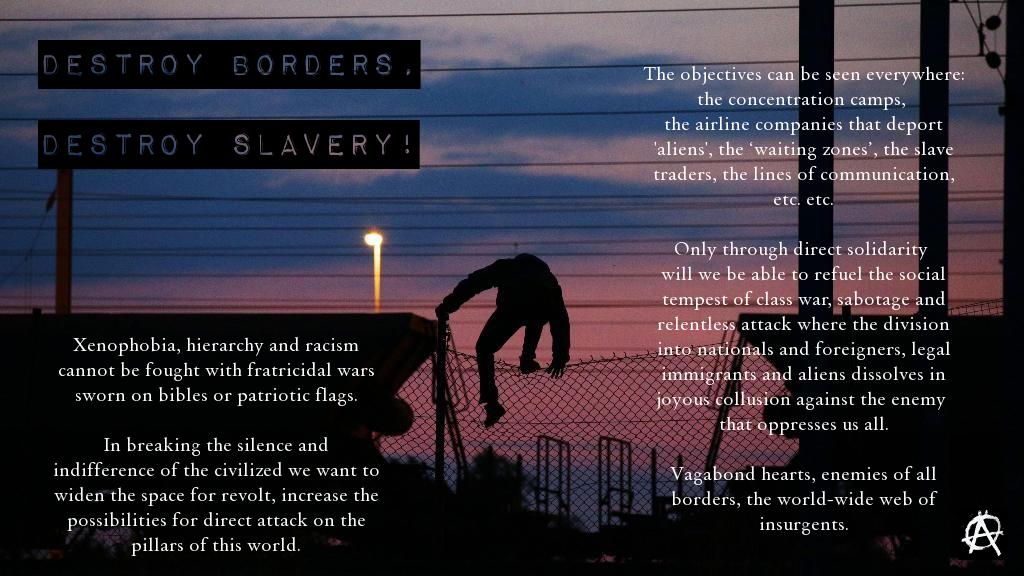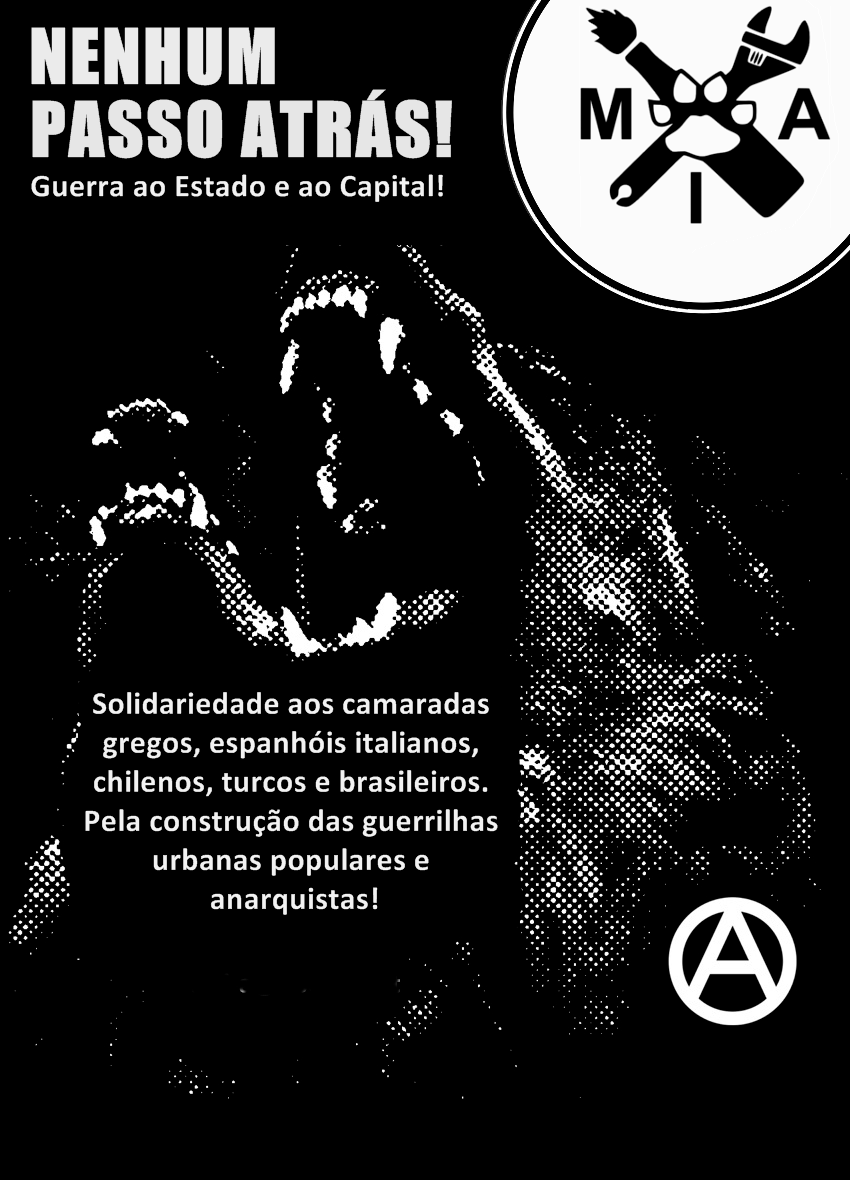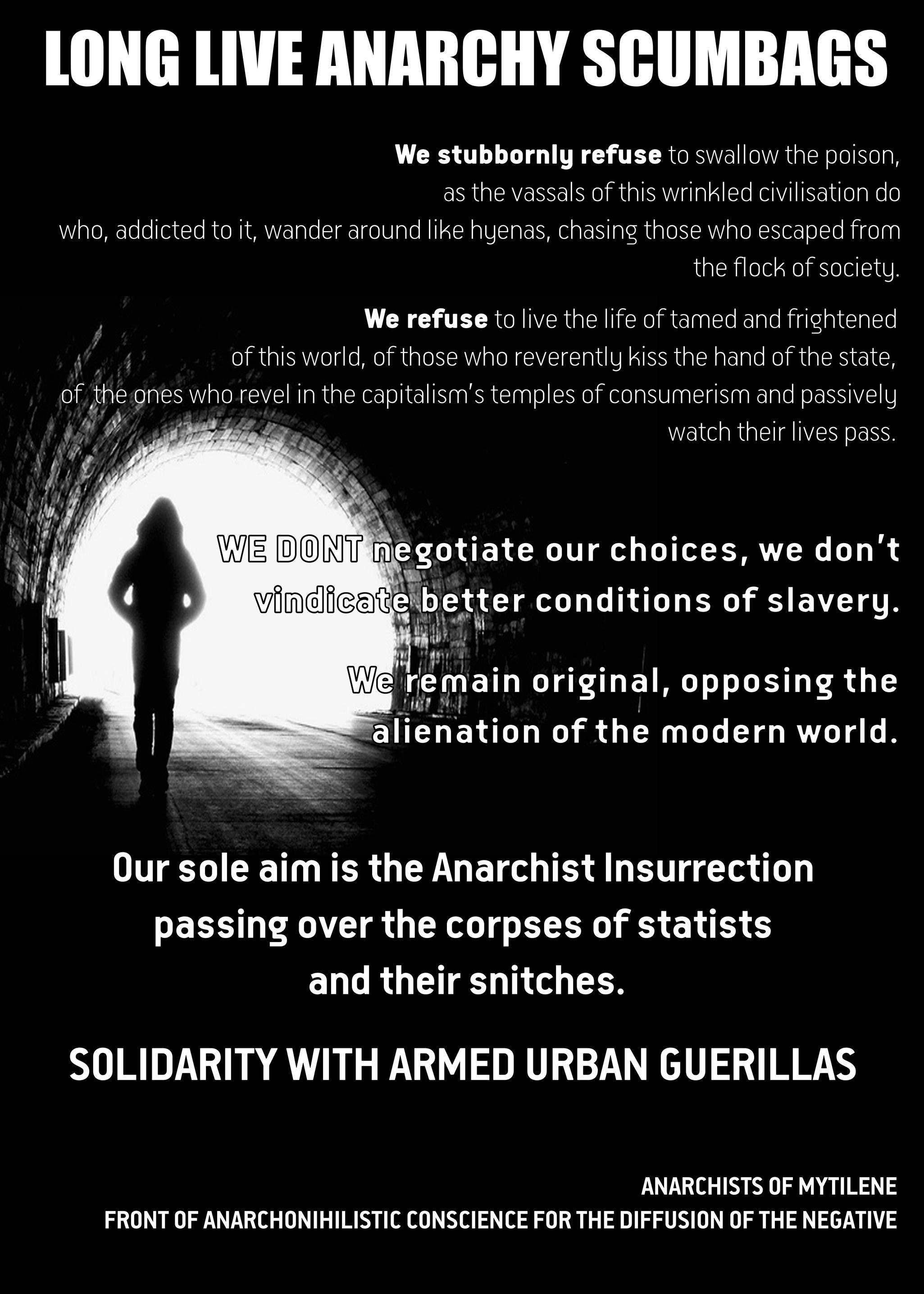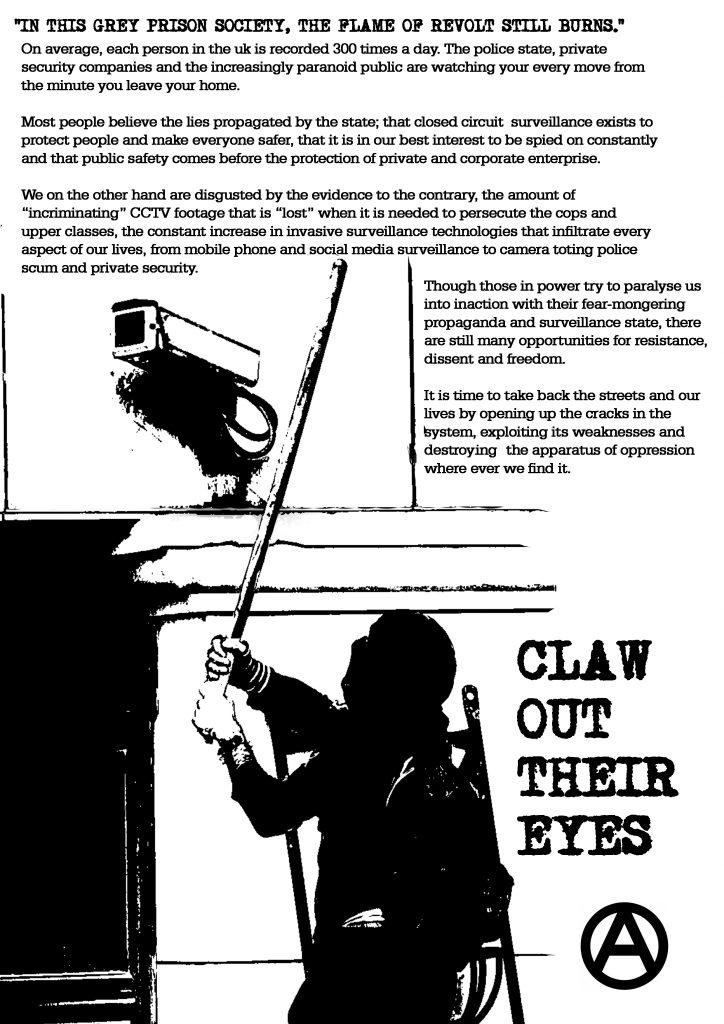Ripubblicata da Untorelli Press
Traduzione italiana di CrnTrn, febbraio 2015. Tutte le note sono del traduttore.
La passione per la libertà
Intervista a Jean Weir

Allora, com’è che ti sei fatta arrestare, il 19 settembre 1994, insieme ad altri quattro compagni (Antonio Budini, Christos Stratigopulos, Eva Tziutzia e Carlo Tesseri) con l’accusa di rapina a mano armata alla Cassa Rurale di Serravalle d’Ala (TN), in Italia? Qual è stata l’evoluzione della tua vita che ti ha portato a quella situazione?
Com’è che mi sono fatta arrestare quel 19 settembre 1994? Beh, ovviamente non si è trattato di un “crimine perfetto”... Un paio di persone del posto hanno visto dei tizi scavalcare una staccionata in località Chizzola e andare nei boschi su per le montagne: ne è seguita una massiccia “caccia all’uomo” e nel giro di qualche ora siamo stati tutti presi. Ma non credo sia questo ciò che intendevate. Mi avete chiesto come la mia vita è evoluta fino portarmi a quel momento. Cercherò di rispondere a questa domanda, che sembra implicare il fatto che quello sia stato una specie di momento culminante verso il quale la mia vita avrebbe teso.
In realtà non è così. Se le cose fossero andate diversamente e non fossimo stati presi, nessuno avrebbe saputo di quel fatto. Sarebbe stato, semplicemente, “un giorno tra i tanti” nella vita di alcuni compagni anarchici.
Non credo ci sia nulla di eccezionale nel fatto che alcuni anarchici decidano di riprendersi una parte di ciò che è stato sottratto a noi tutti – abbiamo da affrontare il problema della sopravvivenza, come tutti gli altri diseredati, e per di più non vogliamo semplicemente “sopravvivere”, ma desideriamo andare oltre le restrizioni della povertà ed agire sulla realtà. Alcuni compagni credono che l’espropriazione sarà un evento di massa nel quale tutti gli sfruttati agiranno insieme, il grande giorno, altri invece non vogliono aspettare all’infinito che questo accada e passando tutta la vita da sfruttati, oppure partecipare allo sfruttamento altrui.
Guardando indietro, quello che è stato eccezionale è il fatto di avere avuto compagni con i quali fosse possibile discutere di tutto e, magari, agire insieme in conseguenza. Dico “eccezionale”, anche se allora era normale. Ciò che approfondisce la conoscenza dell’altro (e di sé stessi) è trovarsi all’interno di una lotta comune – manifestazioni, incontri, discussioni, azioni, ecc. – nella dimensione di un movimento anarchico informale. Le relazioni fra i compagni si approfondiscono, si arriva a conoscere davvero l’altro, non solo per quanto riguarda i nostri scopi, ma anche il modo in cui siamo fatti in quanto individui, la maniera in cui reagiamo, i nostri punti di forza e di debolezza. Penso che, a partire da una situazione di questo genere, sia naturale per dei compagni che si conoscono ed hanno fiducia gli uni negli altri, entrare più approfonditamente in certi argomenti e decidere di sperimentare per far avanzare la propria lotta ed aprire nuove possibilità in ogni campo.
Per gli anarchici, l’assenza di gerarchia concerne anche l’azione. Quando viene portata avanti all’interno di una dimensione progettuale che possiede una vera tensione verso la libertà, la validità di un’azione di un tipo qualsiasi dipende dall’esistenza di tutti gli altri tipi d’azione.
Durante il processo, i media e lo Stato italiano si sono scatenati; ma qual è stata la tua esperienza della solidarietà da parte di altri anarchici e ribelli, durante tutto il procedimento giudiziario e poi durante la detenzione?
In effetti, quei fatti hanno portato a due processi... no tre. Innanzitutto c’è stato il processo per la rapina in questione, poi siamo stati accusati di altre due rapine in quella zona[1], cosa che ha dato origine ad un secondo processo (che è durato molti mesi), durante il quale è emersa una pentita che ha poi portato all’infame processo Marini[2].
I media locali si scatenarono subito dopo la rapina di Serravalle (vicino a Rovereto): c’erano tutti gli ingredienti del cocktail mediatico del “pericolo terrorista”: stranieri, anarchici, armi, rapine, ecc. Ma non è nulla se paragonato a quello che sarebbe successo in seguito, a livello nazionale.
La reazione degli anarchici di Rovereto e dei dintorni fu immediata ed incondizionata. La loro solidarietà fu appassionata e a volte anche giocosa. Attraverso manifesti, volantini, manifestazioni, incontri pubblici, rivendicarono l’identità dei compagni arrestati, difendendo la nostra identità in quanto anarchici all’interno di un’articolata denuncia del ruolo delle banche e affermando la validità della pratica di svaligiarle.
Poco dopo il nostro arresto nacque il settimanale Canenero.[3] Penso che sia giusto dire che anche se prima o poi la rivista sarebbe comunque uscita, per varie ragioni il nostro arresto fu un elemento catalizzatore che contribuì a farla nascere in quel momento. Le sue pagine, attese con entusiasmo, ed il fatto di sapere che compagni a me molto vicini stavano lavorando notte e giorno per farlo uscire, furono una luce brillante che illuminò quel primo periodo in galera. Sono successe molte altre cose, è difficile mettere tutto su carta. Fin dall’inizio, anarchici venivano da tutta Italia ai processi, l’aula era sempre piena e a volte c’erano troppi compagni perché tutti potessero entrare.
Mi ricordo enormi “Baci” e A cerchiate scritte col rossetto su una finestra che dava sulla sala, dopo che quelli che non erano stati ammessi occuparono un edificio di fronte al tribunale e da lì mandarono i loro saluti... la notizia che più di 150 bancomat della zona erano stati bloccati con la colla ebbe il risultato che una delle banche ritirò la richiesta di risarcimento nei nostri confronti... uno striscione con gli auguri di compleanno, srotolato in aula quando una delle udienze coincideva con il mio compleanno... Fuori dalla prigione di Trento furono accesi bengala e sparati fuochi d’artificio, mentre ci trovavamo lì per una delle udienze presso il tribunale locale, cosa che causò la consegna a molti compagni di fogli di via. Quando ero nella prigione di massima sicurezza di Vicenza, un buco schifoso, in particolare la sezione femminile, per Capodanno i compagni noleggiarono un pullman e improvvisarono una manifestazione con bengala, striscioni e palloncini di vernice, un’azione non priva di rischi, perché la prigione di Vicenza è vicina alla base militare americana della NATO. Quando sono uscita, ho poi saputo che era tutto andato bene e che erano poi andati tutti a fare festa fino al mattino da qualche parte su per le montagne. Il giorno dopo un elicottero della polizia fece la sua comparsa nel campo sportivo femminile, dove rimase fino al giorno in cui fui trasferita al carcere di Opera, vicino a Milano. Quella dimostrazione di affetto e di solidarietà contribuì a farmi trasferire da quel posto disgustoso, senza bisogno di fare ricorso a ossequiose “lettere al direttore della prigione” o cose del genere.
Questi sono alcuni dei momenti che mi vengono in mente a proposito di quel periodo iniziale. Più tardi, in seguito all’invenzione da parte di una “ex militante” “pentita” di una fantomatica banda armata a cui saremmo tutti appartenuti, molti compagni furono arrestati oppure dovettero nascondersi per poter continuare la lotta. So che molti dei compagni rimasti ebbero accese discussioni per mettersi d’accordo e decidere cosa fare, ma non conosco quel periodo bene come quello precedente.
Il fatto di leggere le vostre domande mi ha riportata indietro a quei tempi non così lontani e ricordare la solidarietà mi riempie di un’immensa emozione. È stato straordinario. Solo qualcuno che è passato attraverso simili momenti può capire ciò di cui sto parlando e, come potete vedere, non riesco a condensare la risposta a questa domanda in poche linee, anche se tutto quello che ho menzionato non è che una piccola parte di ciò che i compagni hanno fatto, giorno dopo giorno, per anni.
Un comitato anarchico di difesa che era stato formato in precedenza divenne molto attivo per trovarci gli avvocati, coordinare i contributi derivanti dai benefit, ecc. e pubblicare regolarmente notizie su tutta questa storia, che si stava sviluppando in un complesso attacco repressivo contro una larga parte del movimento anarchico.
Il compagno che spediva i vaglia fu accusato di essere il “tesoriere” dell’organizzazione clandestina fantasma inventata dal PM Marini, insieme con i ROS, e fu spiccato un mandato di cattura contro di lui. Il compagno che maggiormente portava il peso dell’attività del comitato fu invece accusato di aver falsificato una nota interna dei ROS, che era stata mandata a Radio Black Out a Torino. Entrambi furono poi assolti o videro le accuse cadere.
Durante tutte le varie fasi della repressione furono stampati migliaia di manifesti e volantini in tutte le principali città e anche nei piccoli centri, dovunque fossero presenti anarchici che volevano dimostrare la loro solidarietà.
Da una semplice questione riguardante pochi compagni presi “con le mani nel sacco”, sulla quale non c'era molto da dire, la faccenda si sviluppò fino a coinvolgere una sessantina di anarchici accusati di appartenenza a un’organizzazione clandestina, insurrezione contro lo Stato, ecc. con pene richieste che arrivavano all'ergastolo.
Tutto si basava sulla “confessione” della fidanzata ventunenne di Carlo, uno dei compagni arrestati insieme a me, che i ROS (Reparto Operazioni Speciali dei Carabinieri) individuarono come una persona giovane e potenzialmente impressionabile che poteva essere spinta a collaborare con la polizia e la giustizia. La ragazza dichiarò di aver fatto parte della “banda” e di aver partecipato a una rapina nella zona di Trento. La maniera in cui la storia fu costruita era così assurda da fare quasi ridere, ma le cose cominciarono a mettersi male – ci furono centinaia di perquisizioni in tutta Italia e molti compagni finirono in prigione, alcuni fecero degli scioperi della fame e furono rilasciati. Ci fu una vasta denuncia di questa montatura contro gli anarchici, che aveva anche attirato l'attenzione della stampa: incontri infiniti, attacchi contro la stampa, gli ingressi della metropolitana incollati il primo giorno del processo Marini, manifestazioni, mostre itineranti, ecc. ecc.
Oltre agli arresti, venivano completamente distorti i metodi anarchici e furono quindi stampate e distribuiti in tutto il paese decine di migliaia di opuscoli che denunciavano tutto ciò. Ci furono molte azioni e volantini e i manifesti venivano ora stampati a livello nazionale, in seguito a numerosissimi incontri fra gruppi ed individui di ogni parte del paese. Ci furono interventi regolari sulle radio libere. Azioni di solidarietà si verificarono anche in Germania, Grecia e Spagna. Una compagna tedesca fece uscire una pubblicazione bilingue, traducendo molti testi italiani - voglio dire testi teorici, non solo legati alla repressione - e organizzò benefit e incontri. Mi è anche stata molto vicina, in molti modi, negli anni in cui sono stata dentro. Ricevevo anche molte lettere, telegrammi, cartoline, che trasmettevano auguri, passione, colore, solidarietà da parte di compagni di molti paesi, incluso il Regno Unito.
Puoi parlarci della tua esperienza in carcere, delle condizioni, delle possibilità di rivolta, ecc.? Com’erano le tue relazioni con le altre detenute?
Un’altra storia lunga... da dove cominciare? Beh, tanto per cominciare in quegli anni non si trattò di un carcere, ma di sette, e passai la maggior parte del tempo sballottata su e giù fra Milano ed il Trentino, ammanettata in un furgone cellulare, sbirciando attraverso i fori nella finestra di metallo per cogliere uno spicchio delle montagne o dei frutteti in fiore, mentre il processo di Trento seguiva il suo corso perverso. Le condizioni cambiavano enormemente da un carcere all’altro e dipendevano da fattori specifici ad ognuno di essi. Ci sono però alcuni aspetti che sono tipici di ogni carcere femminile: sono molto più piccoli rispetto a quelli maschili e spesso hanno meno strutture per scopi educativi o ricreativi, a volte nessuna.
La prima cosa a colpirmi e infastidirmi era che ero sola, cioè ero tenuta separata dalle mie compagne di detenzione che nella maggior parte dei casi dividevano la cella con altre detenute, avendo così ampie possibilità di parlare, ridere e, più in generale, affrontare insieme alla situazione. Eva ed io eravamo tenute separate e per fortuna lei è stata liberata dopo un mese o giù di lì dal nostro arresto. Mi ero già trovata in situazioni simili in passato, quindi conoscevo l’andazzo e mi feci forza. La solidarietà dall’esterno, di cui ho parlato a lungo, certo nutriva quella forza, ma c’erano molte cose che succedevano all’interno e tutt’intorno a me di cui avrei voluto discutere con i miei compagni, e ciò era impossibile. Voglio dire, anche a proposito di cose banali del carcere – e quasi tutto è banale, ma a volte può essere pesante. Gli spostamenti d’aria dei proverbiali “battiti d'ali di una farfalla” possono provocare in ogni istante delle tempeste, come un boomerang d’acciaio, e anche i propri pensieri sembrano prendere (o forse in ogni caso ce l'avevano già) una certa capacità di agire sulla realtà.
Penso che il semplice fatto di rimanere in vita, conservando la propria individualità e tenendo il morale – e la testa – alto sia in sé una forma di ribellione, nel contesto di un’istituzione che è deliberatamente costruita per schiacciare le persone ed umiliarle. Le cose allora erano molto diverse rispetto a com’erano state in Italia negli anni ’70 e ’80, quando c’erano migliaia di compagni in prigione, spesso rinchiusi in carceri di massima sicurezza costruiti apposta per loro. La ribellione era una costante, una necessità e una continuazione della lotta all’esterno, prendendone quasi il posto, prima del dietrofront della maggior parte dei leader marxisti-leninisti.
Oggi, specialmente se donna, puoi trovarti ad essere veramente in poche, dentro, per una qualunque di un gran numero di ragioni (ancor meglio – gli anarchici non si dichiarano prigionieri politici e se finiscono nelle “ali per prigionieri politici” è perché lo Stato li mette là per impedire che “infettino” gli altri prigionieri). In effetti in alcune delle piccole prigioni in cui sono stata rinchiusa, a cominciare da quella di Rovereto, sono stata tenuta separata dalle altre detenute per quanto lo spazio limitato lo consentisse. I secondini non erano abituati a vedere i volantini che arrivavano con la posta, le loro mani tremavano, letteralmente, venendone a contatto e io venivo trasferita il prima possibile.
L’unica cosa che ricordo della prigione di Trento è un terremoto, una notte durante la quale passai l’ora successiva o giù di lì a cercare di decidere cosa fare nel caso di un'altra scossa, finché non mi addormentai. Non tutti gli incidenti di questo tipo hanno un esito felice: 8 prigioniere (e due secondine) morirono intrappolate nell’incendio scoppiato nel carcere delle Vallette a Torino nel 1986. I racconti dei prigionieri di New Orleans gelano il sangue nelle vene, solo per fare un esempio. Non dobbiamo mai dimenticare che, al di là degli aneddoti e dei ricordi, la prigione consiste in tantissime scatole rinforzate in cui milioni di persone in tutto il mondo sono rinchiuse giorno e notte. Sono ostaggi dello Stato e vivono 24 ore al giorno alla mercé di una gerarchia di vili codardi.
Quando l'ala femminile del carcere di Trento venne chiusa fui spedita a Vicenza, esperienza di cui ho parlato prima. La sezione femminile consisteva in due file di celle le une di fronte alle altre. Al mattino le pesanti porte d’acciaio venivano aperte, lasciando chiusa una seconda porta a sbarre. E quella era la “condizione di detenzione” per il resto della giornata. Ragazze pallide e magre passavano tutta la giornata nel letto, perché, anche se c’era un cortile, fuori faceva un freddo gelido (Vicenza è in montagna). L’ora d’aria è stabilita da un atto parlamentare, ma non c’è scritto da nessuna parte una "durata minima". Due ore intere in un cortile gigante in cemento, freddo, gelato, senza niente da fare, erano troppe per la maggior parte delle detenute e così i secondini erano contenti di risparmiarsi il lavoro di aprire e chiudere un numero X di cancelli.
Cominciò così la battaglia, prima nel modo “buono”, facendo presente la situazione al personale medico, scrivendo appelli collettivi al direttore, ecc. senza alcun esito. Era molto difficile parlare con le altre prigioniere perché, a parte l'ora d'aria in cortile, c’erano solo un paio d’ore di “socialità” al giorno, a cui bisognava iscriversi in anticipo, mettendo il nome della detenuta che doveva essere rinchiusa con te o che volevi “andare a trovare”. Ciononostante, riuscimmo a metterci d’accordo di uscire in cortile il giorno dopo e, per protesta, con l'intenzione di rifiutare di rientrare alla fine delle due ore. Questo, nel contesto carcerario, equivale all’insurrezione. Il giorno arrivò. La presenza, giù, dei secondini della sezione maschile era la conferma che i piani collettivi erano stati sventati. Poco tempo dopo (questo avvenne nel periodo immediatamente successivo alla manifestazione di Capodanno), la mia vicina di cella, C., ed io fummo fatte “sparire”: io nella “sezione politica” di Opera, C. in un qualche sperduto carcere di provincia. Tutto questo lungo racconto è solo per cercare di spiegare come il semplice tentativo di ottenere un “diritto” basilare venga considerato una pericolosa minaccia all’ordine e alla sottomissione.
Il fatto è che bisogna cercare di vedere il contesto di cui stiamo parlando. Non entri in prigione dicendo: “wow, un mucchio di persone rinchiuse, questo è un terreno fertile per la ribellione, andiamo!”. Innanzitutto, la maggior parte della gente ha un sacco di problemi e semplicemente non è interessata a sapere come tu ti definisci, e personalmente non cercherei di farlo in altro modo che nella mia maniera di relazionarmi nei loro confronti e nei confronti di quello che ci circonda, anche se in alcuni carceri c’erano delle “politiche” che erano a conoscenza del nostro caso. È una cosa diversa. Penso che, nel corso normale degli eventi, quando sei in prigione il tuo compito sia quello di riconoscere di essere prigioniero e continuare a vivere la tua vita in condizioni “diverse” cercando di contribuire ad alzare il tono di quella che spesso può essere una realtà abbastanza squallida.
La maggior parte delle donne dentro sono in una situazione ben peggiore della nostra. Molte hanno dei bambini, qualche volta a migliaia di chilometri di distanza, e si preoccupano per loro tutto il giorno. Noi siamo privilegiate, perché abbiamo compagni, solidarietà, eccellenti avvocati che spesso sono anch’essi dei compagni.
Detto questo, è stata una bella esperienza incontrare così tante persone differenti e pazze che non avrei mai incontrato altrimenti, a causa di scelte personali e di tutti i ghetti in cui noi “feccia dell’umanità” siamo divisi: zingare, drogate, “assassine”, “leader storiche” di una volta, prostitute, piccole spacciatrici, ecc. Ho vissuto momenti intensi e a volte divertenti. Non fraintendetemi: il carcere non è stato “il miglior periodo della mia vita”. Ma quando un certo numero di esseri umani molto particolari sono costretti, contro la loro volontà, a coabitare, e riescono a stare assieme sulla base di questo denominatore comune e a volte semplicemente ad essere sé stessi, con le loro squisite idiosincrasie, avviene una specie di strana alchimia che trascende ogni muro e diventa un vero momento di libertà e una minaccia per lo status quo del carcere.
Certo, sarebbe stato meglio aver abbattuto per davvero quelle mura. Molte di quelle donne sono ancora rinchiuse. Molte altre le hanno raggiunte.
Mi avete chiesto della solidarietà e non posso concludere questo salto nel passato senza parlare di un esempio indimenticabile di solidarietà da parte delle altre detenute. Come ho detto, ricevevo molta posta che non era ufficialmente censurata, fra cui la collezione completa di Canenero ed una buona quantità di vecchi numeri della rivista anarchica italiana ProvocAzione, che usciva negli anni ottanta. Ad Opera, in seguito a una perquisizione di routine, queste riviste mi furono portate via dalla cella, con poche deboli scuse come “rischio d’incendio” o “ottenute illegalmente”, ecc. Era evidentemente il loro contenuto a non essere per niente apprezzato da quelli che vi si erano imbattuti. Ero furiosa e chiesi che mi fossero restituite le mie riviste.
Chiunque sia stato in carcere sa che non vi è un qualcosa come “domanda e risposta” e che anche la richiesta più insignificante, come il permesso di comprare un paio di calzini, deve passare per un iter che può richiedere settimane. Io non volevo aspettare e, per farla breve, finii con l’improvvisare una protesta col semplice rifiuto di rientrare dal cortile ed essere rinchiusa in cella dopo la passeggiata. Il risultato immediato di ciò fu che riuscii ad ottenere un colloquio col maresciallo della prigione per uomini; alla fine mi furono restituite le riviste e l’odiato caposecondino in carica alla sezione femminile sparì dalla circolazione per qualche settimana, un sollievo per tutte. Il secondo risultato fu che il lunedì mattina fui scortata in una specie di “tribunale interno”, presieduto dal direttore della prigione e alla presenza di secondini, sbirri, psicologi, ecc.
Il verdetto: colpevole di insubordinazione. La punizione: due settimane nella cella di rigore. Ciò fu uno shock per tutte nella sezione, anche per quelle che erano dentro da quasi vent’anni. Le rare punizioni, ad Opera, erano di 2 o 3 giorni. Dopo essere stata controllata dal medico che certificò che potevo sopportare la sentenza (il medico ha sempre l’ultima parola, anche nel braccio della morte...), fui portata giù ai blocchi d’isolamento, per esservi rinchiusa 22 ore al giorno, con i soli oggetti essenziali: le mie riviste anarchiche (mi assicurai di averle), un paio di libri, un dizionario ed una piccola radio.
Alcuni secondini furono incaricati di star seduti dall’altro lato del blindo e scrutarmi attraverso lo spioncino e farmi uscire per la passeggiata, in un giardinetto piccolo e squallido, un’ora al mattino ed una al pomeriggio. Chiunque mi avesse parlato avrebbe ricevuto una punizione simile. Dopo aver passato la maggior parte della notte in una guerra contro le zanzare (era metà agosto, con 40 gradi) mi svegliai al rumore di un numero rap proprio davanti alla mia finestra. Sbirciando fuori potei vedere le ragazze che lavoravano nel giardino di sotto che ballavano in fila fra le piante, rappando. Che figata! Poi, quando uscii per l’aria, tutte le donne della sezione erano alle finestre cantando a squarciagola un intero repertorio di canzoni d’amore e di lotta. Il casino era tale che i secondini dovettero portarmi via da quello sporco cortiletto, verso i campi sportivi, per la passeggiata due volte al giorno.
Per il resto basti dire che per tutta la durata dell’isolamento tutto il cibo del carcere finiva nel cesso, visto che ricevevo un rifornimento costante di cibo fresco, caffè caldo, ecc., grazie all’astuzia e alla creatività di cui solo chi è rinchiuso suo malgrado è capace, sotto il naso delle spie in uniforme fuori dalla cella e dalle guardie armate che fanno la ronda intorno alle mura. Finite le due settimane ci fu una grande festa nella sezione!
Una volta uscita dal carcere, come ti sei sentita a “ritornare” nella “società”?
Società? E che cos’è? Penso che fin dal giorno dalla mia nascita ho sempre vissuto la società come una morsa d’acciaio. Le prime due settimane all’asilo dovettero chiudermi a chiave in classe. Forse il momento in cui sono stata più vicina all’essere “nella” società è stato in carcere. Non puoi sfuggire a questo stato di cose, a meno che, come dicevo, non ti dichiari “prigioniero di guerra” e passi il resto della tua condanna da solo con uno status speciale. La prigione è un microcosmo del mondo fuori, una specie di caricatura in cui sei incastrato, senza un posto in cui nasconderti, e così vieni socializzato in una certa misura, che ti piaccia o no, per il bene degli altri detenuti e per fare qualcosa del tuo tempo. Ma sempre entro limiti ben precisi. Come la società fuori, la prigione ha un effetto polarizzante: segrega ed esclude i ribelli e spinge altri detenuti verso l’integrazione e la partecipazione alla propria prigionia. I momenti in cui mi sono trovata a qualche centimetro da questa oppressione partecipativa sono stati per me i peggiori ed il tipo di realtà verso cui essa tende mi riempie di disgusto. Ti piacerebbe sputare in un occhio alla secondina e dirle di levarsi quel sorriso dalla faccia, quando viene ad aprirti il blindo al mattino, ma puoi anche finire dicendole “buongiorno”. Di recente un compagno italiano mi ha raccontato che quando era in carcere l’anno scorso c’erano dei vecchi militanti delle Brigate Rosse che chiamavano sempre i secondini “stronzo” o “pezzo di merda” e quanto gli altri detenuti li invidiassero per questo. Se loro ci avessero provato, sarebbero finiti neri di lividi e con qualche costola rotta.
In generale, devi imparare a contenere il tuo disgusto per l’intero baraccone. Una volta uscita restai ai domiciliari per un bel po’, poi tornai a Londra, visto che avevo un’altra piccola condanna pendente in Italia per un furto d’auto legato alla rapina. Scivolai pian piano nella mia vita ghettizzata qui. Senza orgoglio, devo dirlo, perché una tale vita è piena di compromessi, come ogni altra. Non c’è nessuna vera lotta qui, nessuna tensione nel senso di attaccare ciò che opprime te e tutti intorno a te. Puoi diventare un attivista frenetico oppure puoi utilizzare il tuo tempo per cercare di riflettere sulla situazione, “socializzarti” in qualche modo con l’ambiente che ti circonda e continuare ad andare avanti meglio che puoi con la tua progettualità, sempre nell’ottica di cercare delle affinità e degli sbocchi per la lotta così come vuoi portarla avanti. Così, anche in questa prigione a cielo aperto, sei un disadattato, un marginale che interpreta un ruolo e rispetta le “regole della società”.
L’Italia ha una lunga storia insurrezionale, sia per quanto riguarda i tempi recenti, sia per quelli più lontani. Puoi parlarci delle lotte sociali a cui hai partecipato laggiù?
In Italia, negli anni ’70 e ’80, anche se c’era un proliferare di organizzazioni clandestine che avevano dichiarato guerra allo Stato, c’era anche un movimento insurrezionale diffuso e ciò era sicuramente eccitante, era nell’aria che respiravi, attorno a te. C'erano numerosi casi di occupazioni di massa di case, di università, di rifiuto di pagare biglietti, viaggi del bus, pasti, ecc. In città coma Bologna c’erano centinaia di giovani che semplicemente si rifiutavano di pagare. Venivano compiute molte piccole azioni di attacco da parte di individui o di gruppi molto piccoli, senza tutta la retorica delle organizzazioni armate, e ciò ebbe un profondo effetto sulla parte del movimento anarchico che spingeva in quella direzione. C’era sempre un forte senso della progettualità e dell’essere parte della lotta per la libertà insieme ad altri compagni all’interno di questo movimento informale.
Ciò si sviluppò in quello che alcuni anarchici chiamano il “metodo insurrezionale” della lotta. Questa interpretazione, basata su una precisa ipotesi organizzativa, cerca di arrivare a una partecipazione delle masse, accanto agli anarchici, contro un obiettivo definito. Questo richiede un impegno costante nella lotta per un certo periodo di tempo. Non si tratta di un piccolo gruppo di anarchici che decide di attaccare un particolare aspetto del potere, ma di un tentativo di coinvolgere un grande numero di persone che si autoorganizzano in un proliferare di organismi di base, nuclei, leghe o comunque decidano di chiamarsi, e attaccare l’obiettivo tutti assieme. L'idea di questo modo di organizzarsi è prevenire l'instaurazione di gerarchie, estendere e moltiplicare l'orizzontalità e fare in modo che, una volta in vista dell'obiettivo, gli individui coinvolti sperimentino un cambiamento qualitativo nel loro rapporto con il potere (assenza di delega, decisioni prese in prima persona, creatività, ecc.), la lotta possa anche andare oltre l’obiettivo.
Ho avuto la fortuna di vivere un’esperienza di questo tipo, anche se il risultato finale non fu poi quello che tutti desideravano e per il quale lavorammo duro, ma ciò non importa. Il periodo sono gli anni ’80, il luogo Comiso, in Sicilia, dove vivevo in quel periodo. Gli Americani avevano deciso di collocare alcuni missili Cruise in quella base militare e a livello locale ciò provocò un ampio dissenso. Manifestanti anti-nucleare, il Partito Comunista, il Partito Socialista, i Verdi, ecc. tutti protestavano con grandi manifestazioni o con picchetti pacifici davanti alla base. Gli anarchici del posto decisero di smarcarsi da questo circo e agire nel senso di una lotta che doveva durare nel tempo, nella logica di una ribellione di massa. L’essenza della lotta anarchica sta nei mezzi utilizzati, non nei risultati.
Stilammo volantini che analizzavano le ragioni, non solo militari, ma anche sociali ed economiche, spiegando che la sola risposta seria a una tale progetto di morte era occupare la base e distruggerla e ne stampammo migliaia di copie su un vecchio ciclostile a mano, usando matrici che ci avevano dato alcuni compagni di Class War in Inghilterra. Nessuno aveva somme di denaro significative e quando cominciammo era tutto improvvisato. Riuscimmo a mettere insieme un sistema di amplificazione e andavamo in giro tenendo (di solito Alfredo [Bonanno]) combattivi ed inequivocabili comizi nelle piazze dei villaggi circostanti, a cui partecipava la maggior parte della popolazione maschile del luogo. Producemmo volantini indirizzati alle donne e andando per le case a distribuirli, improvvisando capannelli con alcune di loro. Producemmo volantini indirizzati agli operai della raffineria Anic (che, quando la DIGOS ci arrestò, rifiutarono di tornare al lavoro finché non fummo liberati) e agli studenti, che distribuivamo davanti alle scuole. Alcuni ragazzi si rifiutarono di entrare a scuola e partirono in corteo riempiendo una delle piazze. Fu allora che vidi come il potere lavora realmente a livello locale: il capo del PCI venne a bussare alla nostra porta, proponendoci di “lavorare insieme”. Inutile dire che non fu il benvenuto.
In quel periodo ci avevano prestato una vecchia casetta, visto che alcuni di noi vivevano a più di 100 km di distanza. I comizi, i volantinaggi, i manifesti, ecc. avevano fatto sì che alcune persone di provenienza e percorsi di vita differenti (studenti, camionisti, braccianti) si trovassero d’accordo con la necessità di distruggere la base e formarono “organizzazioni di base” minime a cui diedero il nome di leghe, in mancanza di una parola migliore. Queste leghe, che spesso consistevano di due o tre persone, ma che avevano la possibilità di espandersi e moltiplicarsi visto che la lotta si intensificava, iniziavano ad avere bisogno di un luogo che fungesse da punto di riferimento e di coordinamento, per esempio per potersi riunire, scrivere e stampare volantini, ecc. A questo scopo fu affittato un piccolo locale a Comiso a cui si faceva riferimento come al “Coordinamento” delle leghe autogestite contro la base missilistica di Comiso. Erano queste le persone che avevano davvero la possibilità di distruggere la base – con i loro colleghi, vicini, famiglie, bestiame, trattori, scavatrici, ecc. Questo era il sogno.
A parte la repressione pura e semplice c’era però una combinazione di ostacoli, inclusa la mafia locale. Una notte, due individui a volto coperto irruppero a casa nostra armati di fucile e spararono un colpo che trapassò i pantaloni di Alfredo. Poi c’era il Partito Comunista, che come da copione svolgeva il suo ruolo di pompiere e, ultimo ma non per questo meno importante, lo stesso movimento anarchico ed i nostri propri limiti. Non è possibile adesso entrare in tutti i dettagli di quella lotta, ma guardando indietro penso che si dovrebbe fare un resoconto di quel tentativo, che fu un’esperienza molto reale con un forte aspetto sperimentale e teorico e quindi patrimonio di tutti.
Il progetto editoriale a cui partecipi – Elephant Editions – è noto per essere il principale traduttore di Alfredo Maria Bonanno e altri anarchici “insurrezionalisti”. Anche se non vogliamo alimentare o creare alcun culto della personalità, puoi spiegare perché le idee di Alfredo e degli altri autori che pubblicate sono importanti per la lotta per abbattere le condizioni che ci opprimono?
Come prima cosa stiamo parlando di idee, merce abbastanza rara di questi tempi. Idee con una carica sovversiva, che incontrano e stimolano altre idee che ci portano fuori dalla palude di opinioni e tolleranza e ci aiutano a raggiungere la lucidità necessaria per agire sulla realtà che ci opprime e trasformarla. Devo dire che non mi sono mai avvicinata a nessuno dei testi che ho tradotto e poi pubblicato altrimenti che per la semplice ragione egoistica di voler entrare nel dibattito e chiarirmi delle idee. Quando alla fine (dopo un lungo travaglio) un testo diventa un qualcosa di tangibile in inglese, voglio che anche altri lo leggano. Per alcune (non molte) persone leggere testi del genere è un’esperienza nuova, una scoperta di sé stessi provocata dall'incontro con idee messe per iscritto con una certa chiarezza. Le tensioni che già sentiamo bruciare in noi diventano più chiare, è più facile coglierle ed assimilarle con il fine di agire. Così il testo prende vita propria, fa la sua strada nel contesto della lotta, contribuisce a dare ai compagni che lo desiderano uno strumento per riconoscere e valorizzare le proprie idee e i propri sogni, trasformandoli in un elemento di forza nella vita e nella lotta. Il testo diventa quindi sia un’esperienza soggettiva, sia una “cosa” fisica che, attraverso le vicissitudini del suo viaggio attraverso lo spazio sociale e ideale, diventa un elemento che crea relazioni informali fra singoli compagni. Oltre a tutto ciò, abbiamo bisogno di analisi sull'economia, le nuove tecnologie, i nuovi aspetti del potere e della lotta, i nuovi nemici e i falsi amici. E, diciamocelo, molti di noi sono pigri o mancano di metodo quando si tratta di acquisire delle conoscenze. Senza idee, analisi e progettualità non siamo nulla, mere astrazioni, costruiamo castelli in aria, con l’aria stantia delle strutture formali e della loro ossessione organizzativa. Comunque, la struttura della lingua italiana, e in particolare di questi testi, è completamente diversa dall’inglese; mi serve sempre molto tempo per renderli in qualche modo leggibili e per seguire l’argomentazione. È un po' un viaggio, in particolare quando quei compagni che ho tradotto, Alfredo e altri, sono i miei compagni di lotta, abbiamo vissuto l’esperienza pratica di queste idee che provengono dallo sviluppo del movimento nel corso dei passati decenni. Credo che queste idee, o teorie, siano un contributo importante alla lotta oggi, perché arrivano da quella parte del movimento che non fa riferimento ad alcuna organizzazione fissa o struttura formale e vuole attaccare direttamente l’oppressione in tutte le sue forme.
In effetti, l’attacco e la teoria dell’attacco, che per gli anarchici sono la stessa cosa, sono l’elemento essenziale del movimento informale, senza il quale esso esisterebbe solamente di nome. Vi è perciò anche un forte elemento critico in questi scritti, una critica dell’organizzazione anarchica stabile, come il sindacalismo oppure le federazioni basate sui numeri, limitata e anacronistica per quanto riguarda l'attacco. Allo stesso tempo vi è una critica dell’organizzazione clandestina e dell’“attacco al cuore dello Stato”, che era di gran lunga prevalente negli anni ’70, in modo particolare in Italia. La maggior parte di queste organizzazioni erano di matrice marxista-leninista, ma alcuni anarchici provarono a realizzare l’impossibile, creandone una versione “anarchica” che finì col cadere nelle contraddizioni di ogni istituzione clandestina stabile. Credo anche che molti anarchici all'epoca sentissero una pressione considerevole che li spingeva a creare tale organizzazione, al fine di essere “nella realtà della lotta”. Le teorie di cui stiamo parlando valorizzano invece la formazione di piccoli gruppi, non appesantiti da preconcetti ideologici, che agiscono direttamente sulla realtà, senza alcun senso del sacrificio, ma per ottenere immediatamente il proprio piacere e la propria libertà, nel quadro della libertà di tutti.
Un’altra componente essenziale degli scritti di cui stiamo parlando è l’analisi dei profondi cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi tre o quattro decenni e hanno influenzato in tutto il mondo la maniera in cui funziona lo sfruttamento e la lotta contro di esso. Le “nuove tecnologie”, che oggi molti giovani compagni vivono come normali, hanno infatti cambiato il modo in cui il funziona il mondo.
L’intero impianto della produzione, incluso quella del cibo, l’estrazione di combustibile, ecc., si sono spostati dall’Europa all’Asia e all’Oriente, secondo un colossale progetto di ristrutturazione che in alcuni paesi ha incontrato una ribellione giunta quasi al punto di insurrezione generalizzata. A ciò è seguito un cambiamento radicale delle esigenze educative del sistema e un diffuso appiattimento culturale, privilegiando infinite catene di dati che non ci portano da nessuna parte.
Bisogna aggiungere che una volta che certi testi esistono in inglese, ahimè la lingua del nuovo ordine mondiale, vengono tradotti nella propria lingua da anarchici di altre parti del mondo che vi hanno trovato qualcosa di interessante, e questa è una delle cose che mi ha fatto maggiormente piacere in tutta questa impresa.
Ancora due parole sul concetto di “culto della personalità”, visto che ne avete parlato. Penso che in generale questo concetto sia estraneo agli anarchici. Gli anarchici vengono giudicati dagli altri compagni in base a ciò che essi dicono e fanno e la coerenza fra questi due fattori, non attraverso diatribe a proposito delle loro qualità personali, vero o inventate, come avviene in organizzazioni che si basano su leader carismatici o cose simili, come in Russia dopo la presa del potere da parte dei bolscevichi. Anzi, si tratta del contrario. A volte ci sono attacchi personali che prendono il posto della critica dei metodi esposti da certi compagni, quando alcuni settori del movimento trovano che il loro status quo sia minacciato da tali metodi. Ciò è più facile che attaccare le idee in sé ed opporre altre idee che possano essere più efficaci, chissà? Ma, come ho già detto, non è questa una caratteristica autentica degli anarchici che per definizione negano il concetto di leader e allo stesso tempo esaltano l’individuo, ogni individuo, in una dimensione di eguaglianza.
[1] Si tratta di altre due rapine in banca avvenute a Ravina il 20 luglio 1994.
[2] Per quanto riguarda il processo contro molti compagni anarchici, orchestrato dal PM Antonio Marini con l’aiuto dei ROS e della “pentita” Mojdeh Namsetchi, e finito con condanne pesantissime.
[3] Canenero, settimanale anarchico; uscì dal 28 ottobre 1994 al 17 gennaio 1997. Ne furono pubblicati 45 numeri (più un’edizione “speciale repressione” dal titolo “Incontrollabili”, del gennaio/marzo ’97).