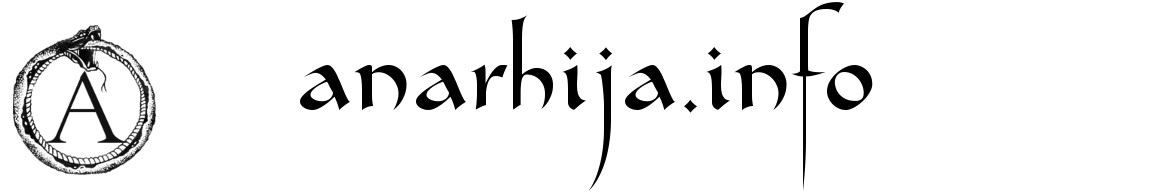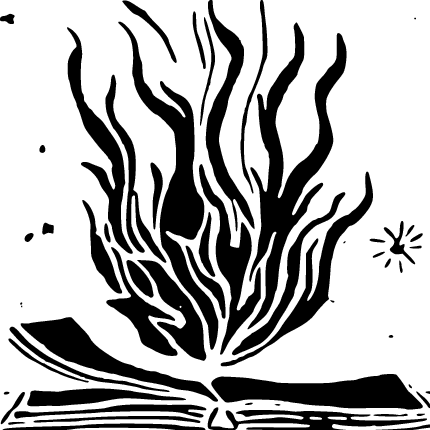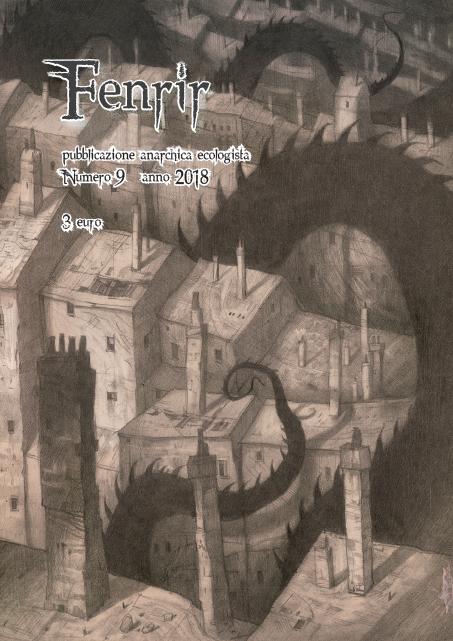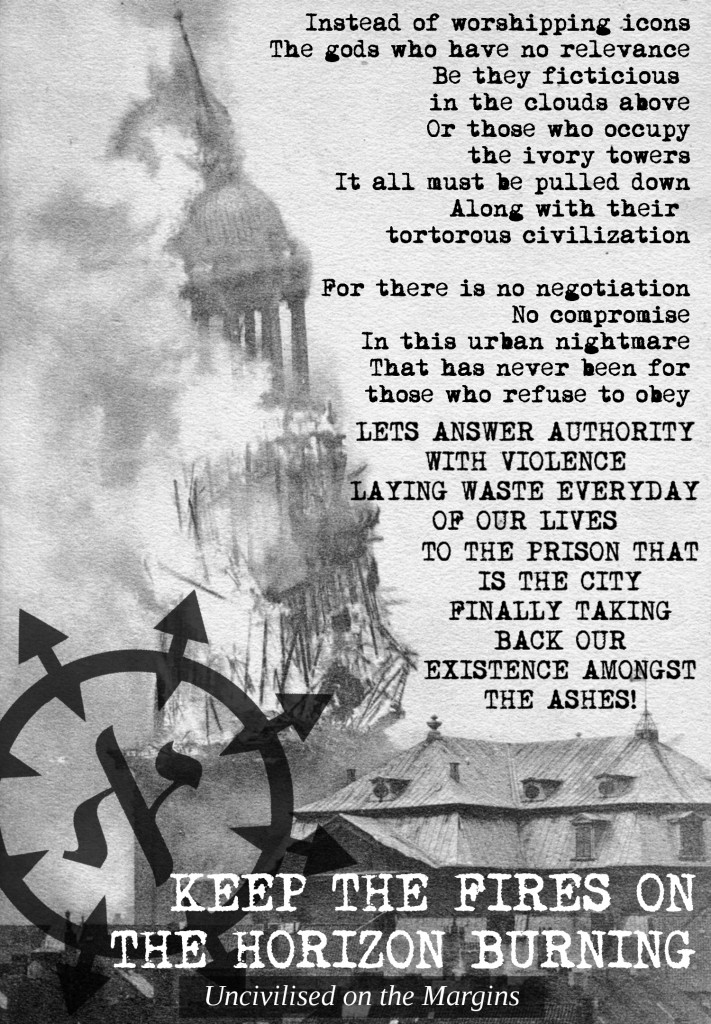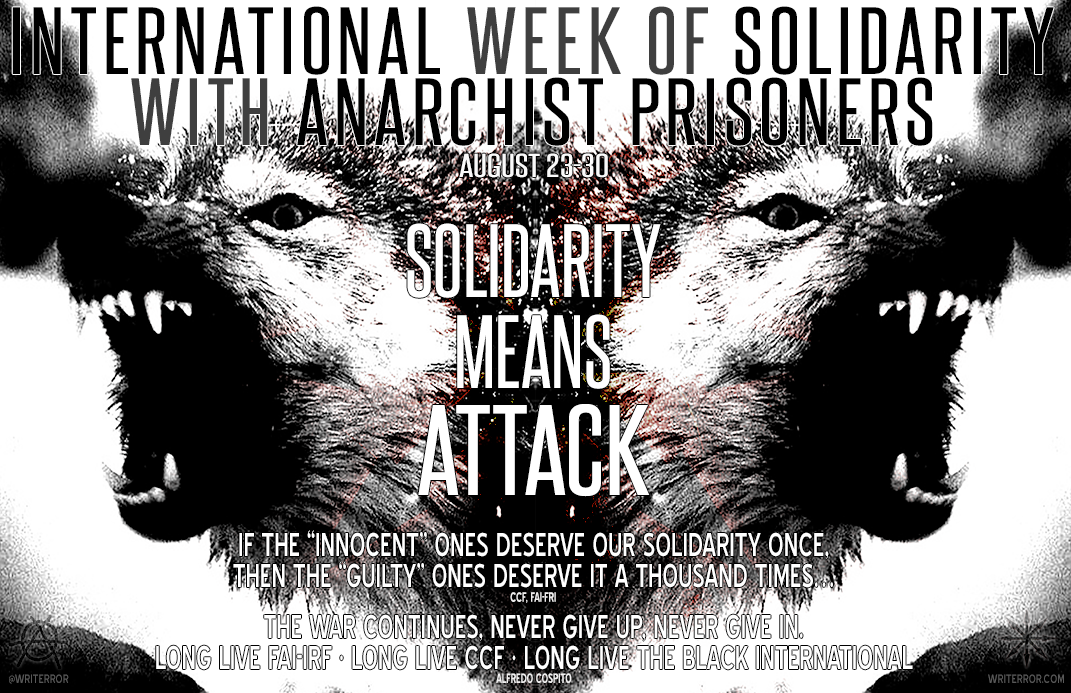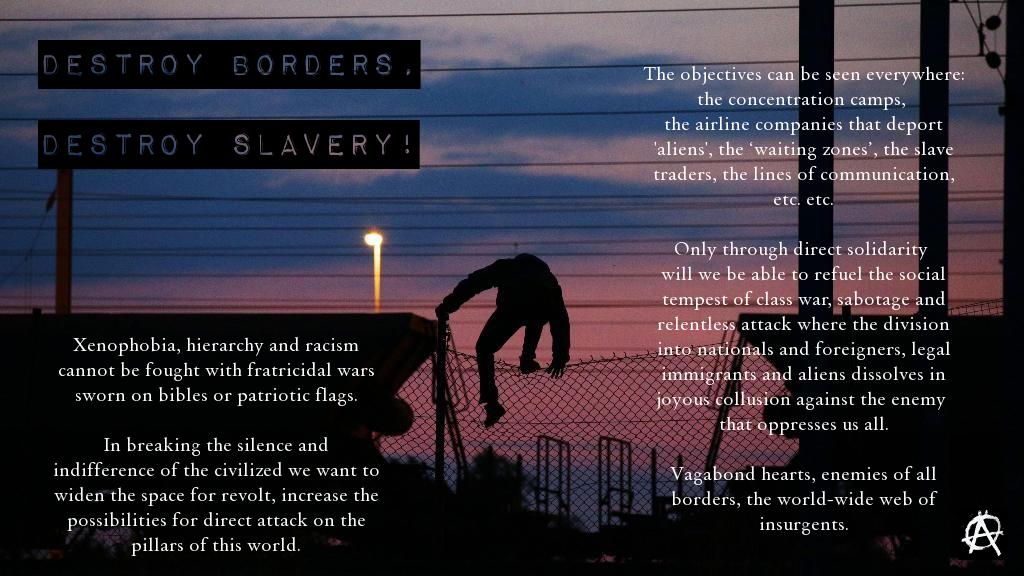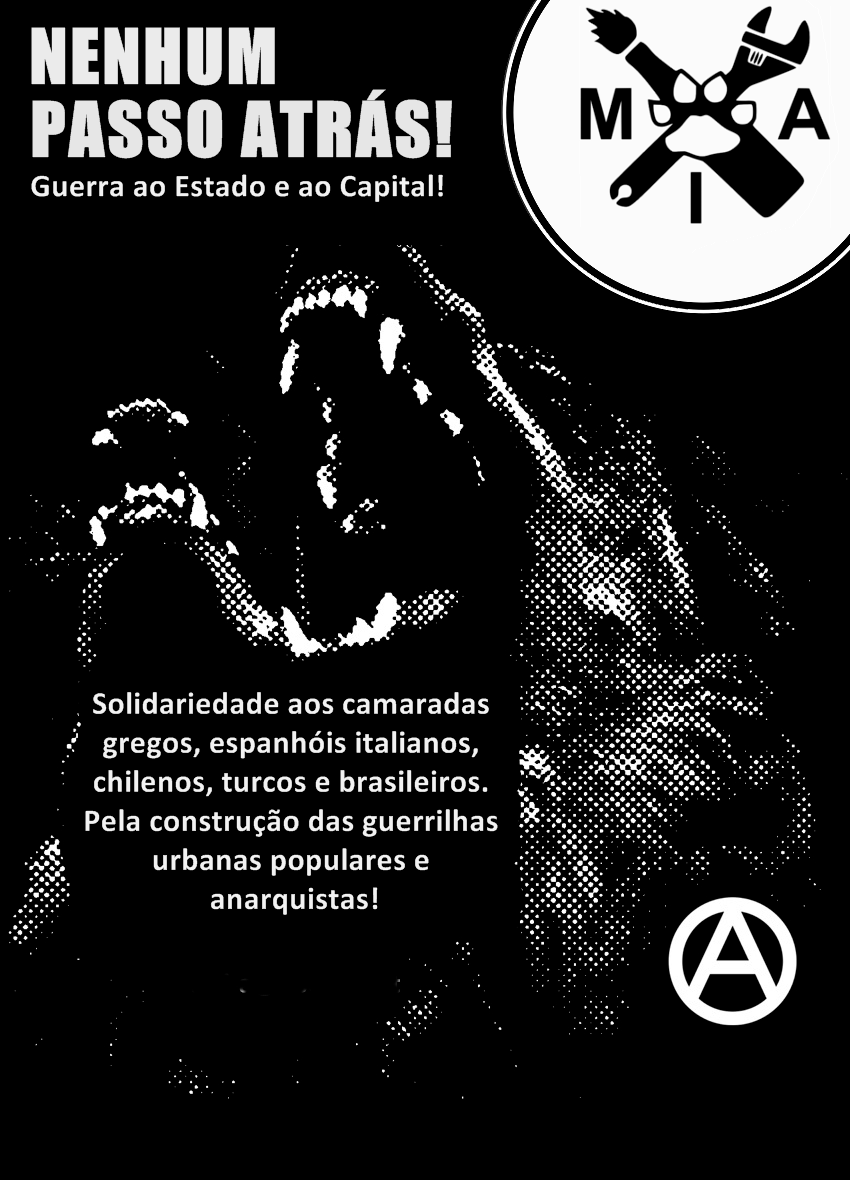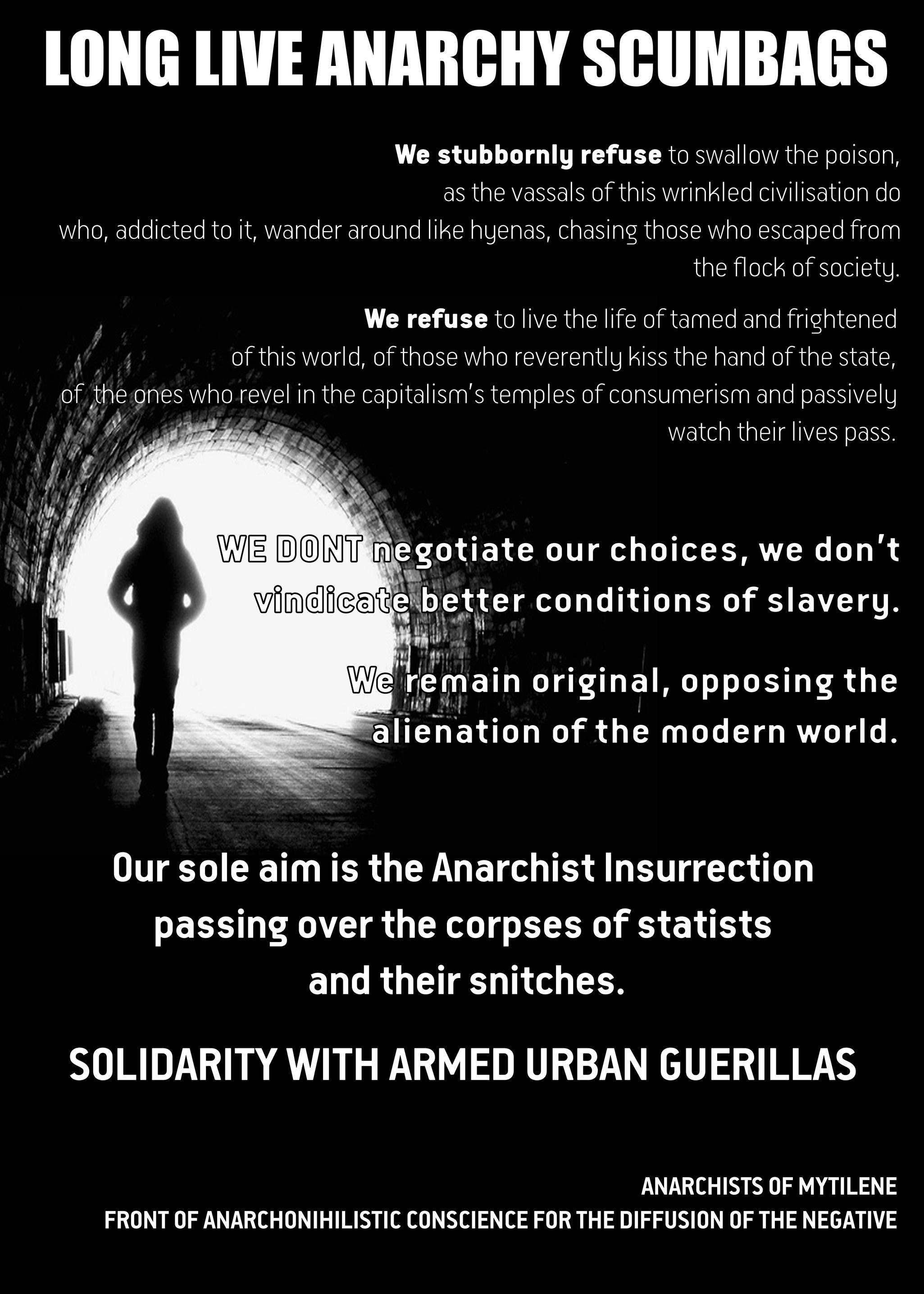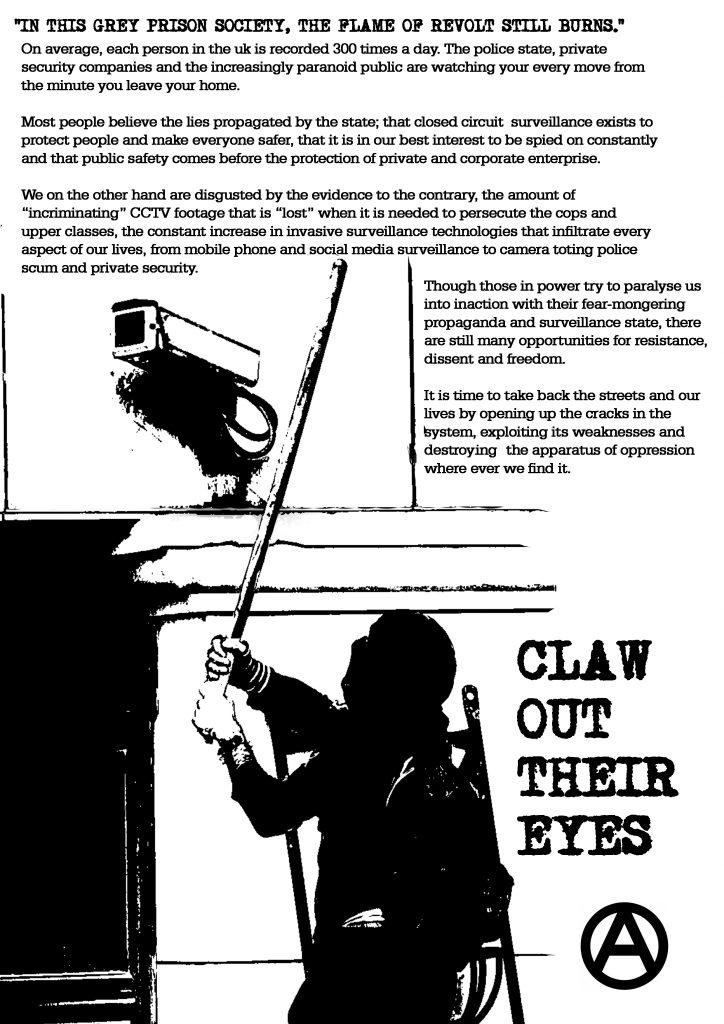Velocità

Tutti abbiamo bisogno di raggiungere uno scopo. Ci affanniamo per questo e ci diamo continuamente obiettivi da raggiungere.
Quello che sta lontano da noi ci angustia, quando non ci preoccupa nel senso pieno del termine, quindi vogliamo raggiungerlo, se non altro allo scopo di possederlo, e quindi di controllarlo. Ogni viaggio è un modo di fuggire alle proprie paure.
Ma non esiste un obiettivo innocente, una stazione di arrivo che non comprenda in sé qualcosa di spaventoso, di concluso e quindi di mortale. Lo scopo non è mai privo di conseguenze, senza che ciò possa indicare una differenza esatta con quello che siamo, una specie di sostituzione reciproca, come accade poniamo con la parola. Nell’obiettivo c’è la persistenza necessaria di tutte le possibilità, contraddizione dell’irripetibile che si ripete proprio perché si trasforma sempre. Più andiamo veloci verso la destinazione, più sfuggiamo alle nostre possibilità di capire, più si affievolisce la cognizione che abbiamo del nostro destino. Ciò causa un intestardirsi della coscienza nella sua ripetitività, difesa e tana contro la paura.
In questo eterno pulsare si dà tutta la realtà, non un singolo viaggio. Nell’apparente ripetizione si delinea per intero la struttura dell’esistente, mentre nell’impossibilità di una ripetizione identica a se stessa si delinea per intero la tragedia di una corsa che non ha mai fine, restando comunque priva di senso.
Possiamo parlare del viaggio, ma per capirlo dobbiamo esserci dentro, essere nello spostamento verso qualcosa di diverso, dove il contenuto di questo spostamento è il rischio stesso, non una riflessione sul movimento. Ma parlare della velocità, come dello spazio o del tempo, contrassegna sempre una distanza, un’incolmabile distanza, e questo sarà il campo di percorrenza dell’itinerario, il territorio del dire che farà da velo al territorio da percorrere, velo che non può nascondere tutto, prima o poi la paura dell’ignoto viene fuori, e non saranno certo le parole a superare questo abisso.
La spaventosità del punto di arrivo la nascondiamo in molti modi. Ad esempio banalizzandola, trasferendola nell’oggettività da quattro soldi della vita quotidiana, del di già conosciuto. Non c’è viaggio nuovo che non ci affascini e non ci faccia paura nello stesso tempo, viaggio all’interno del quale il tempo non si allunghi in maniera incredibile, per poi riaccorciarsi quando quell’itinerario è già sperimentato.
Per un attimo, come i fuochi d’artificio, ogni incertezza sfuma nella sua massima estensione. Ma non esiste certezza pensabile, né sincronia deliberata di meccanismo che possa resistere a lungo. Ogni riproduzione meccanica, rumorosa e utile, ogni cartolina pubblicitaria di luoghi e stazioni d’arrivo, sacrifica se stessa all’imprendibile attimo dove somiglia dolorosamente alla stazione di partenza, ogni durata appare per quella che è, un’illusione senza gusto. Lo spazio nasconde un segreto che svela solo nell’angoscia del movimento, nel disperato tentativo di capire il perché di quello che viene dopo, senza legame e senza ragione con quello che è di già accaduto prima. Questo segreto è dato dal suo carattere istantaneo. Non è possibile parcellizzarlo. I chilometri sono un’illusione della tecnica che il brivido della coscienza continua a rifiutare. Perciò corriamo a dismisura, su mezzi sempre più veloci, su treni e auto e aerei, verso la nostra distruzione. Perciò non ne possiamo fare a meno.
Proponendo la distruzione di quello che la tecnologia dell’alta velocità ci mette davanti – oggi il treno, domani un altro mostro dello stesso genere – non ci illudiamo di acquietare con questo i nostri sogni o le nostre paure. Non vogliamo rendere la realtà più facile, non vogliamo conservare le cose nella loro stesura precedente nella prospettiva di future utilizzazioni “buone”, non persuadiamo nessuno, né raccogliamo proseliti.
Sappiamo che la fuga dalla solitudine è anche la nostra fuga. Non ci atteggiamo a portabandiera di teorie quietiste che non ci interessano. Vogliamo solo entrare nella nostra fuga, essere noi la nostra velocità, decidere noi i tempi e i modi in cui realizzarla, anche nella più stupida delle maniere, anche correndo in motocicletta, quando il vento ti fa uscire a forza le lacrime dagli occhi e sai che un piccolo scatto del polso potrebbe costarti la vita.
Ciò comporta di per sé una distanza dalle mode, una igiene culturale che non è necessariamente contrapposizione di principio, che suonerebbe meglio come snobismo. Il conformismo è una malattia dietro l’angolo cui non è facile sfuggire solo con la forza di non mettersi d’accordo. L’avere torto può essere una sorta di prova indiretta che ci si trova su di un sentiero interessante. Ma come scoprire questo sentiero? Dove trovare la forza di avere torto?
Nelle nostre scelte degli obiettivi da raggiungere, delle stazioni d’arrivo, c’è sempre qualcosa di contraddittorio e di non molto chiaro che si nasconde dietro una pretesa evidenza. Siamo sollecitati da qualcosa che ci manca. Questa mancanza la riconfermiamo puntualmente nel movimento dell’accumulo, nel complesso groviglio delle iniziative che prendiamo, le quali restano in gran parte inespletate. Più restiamo in queste frenetiche vicende del fare accumulativo, più immaginiamo e progettiamo (spesso senza neanche avere idea dei mezzi necessari per realizzare quello che ci proponiamo), più quelle possibilità ci sfuggono, più ci avviciniamo all’accumulo, più mettiamo carne sul fuoco, più ci sfugge il senso della possibilità “altra” del meccanismo stesso. In questo movimento ci concediamo all’improbabile rielaborazione della nostra vita, alle visite inaspettate, all’avventura e al caso codificati, alle soluzioni impreviste ma ortodosse. Ci permettiamo desideri che immaginano la scomparsa della distanza, che costituiscono avvicinamenti, anzi producono accelerazione del passaggio tra lontananza e riaccostamento.
È importante capire che ogni viaggio può avere un senso vitale per noi solo se, attraverso l’inquietudine, non siamo più in condizione di prevedere il desiderio della destinazione, solo cioè se riusciamo a non desiderare nei suoi dettagli quello cui stiamo andando incontro. Questi dettagli infatti, fissando condizioni di sicurezza, impediscono il rischio e disegnano un itinerario turistico conosciuto in partenza. Per spezzarli dobbiamo volere e amare il nostro destino, essere fuori dalla paura.
Sono molte le maniere di muoversi. Ci si può muovere per paura, ed anche per temerarietà. Mai per sincerità. Nel viaggio c’è sempre un tentativo di nascondimento. Difatti si può rimettere continuamente tutto in gioco solo non rivelandosi a se stessi, immediatamente, per quello che si pensa di essere. Il bilico tra i due versanti consente un gioco di astuzie praticamente infinito. Nessun movimento della coscienza è asettico. Non avviene mai sulla base di una ipotesi da verificare. Non c’è mai una condizione che possa garantire una pacifica e distaccata visione del mondo.
Il luogo del viaggio dovrebbe essere quello della scoperta, l’itinerario uno dei momenti in cui ci si trova al cospetto di se stessi. Si potrebbero così cogliere, non disvelare ma cogliere, il senso degli opposti contrasti, il rapporto reale che esiste tra la destinazione e il suo raggiungimento. Nel viaggio potremmo trovare il primo segno della verità che traluce dietro la simulazione. Ma, per far questo dobbiamo rompere l’accordo di non belligeranza con noi stessi, dobbiamo metterci a rischio. Ogni accordo è semplicemente simulato, non produce chiarezza, mette tutto a tacere, sigilla l’archivio. Ma quando il sigillo viene apposto, concordando tutte le contraddizioni, la verità è di già morta da un pezzo. L’itinerario è quindi crescita delle meraviglie, aumento dei meccanismi di copertura, non semplificazione, non distinta ricerca delle componenti. Ogni viaggio è trasferimento in blocco al di là della trama che da sempre si continua a tessere, ed è anche ricerca della morte, guardare verso il territorio che non si conosce, ma che ci ha tante volte visto ospiti coraggiosi e coinvolti.
Si potrebbe, come Apollinaire al cospetto della prima automobile a Parigi, gridare: plus vite, nom de Dieu, plus vite, più presto, perdio, più presto. Il gioco senza fine, quando ha inizio, risulta troppo pesante se a giocarlo si è in più di uno. Ora, il giusto valore dell’impossibile può essere considerato solo da chi ha deciso di possederlo, anche a costo della propria messa a repentaglio, oltre la singola, miserabile, possibilità di vita. Molti pensano che tutto ciò corrisponda esattamente alla debolezza generalizzata, specchio fedele di un profondo cambiamento delle strutture sociali. Debolezza che non è poi molto difficile definire come crisi o come decadimento e altri consimili concetti. Non sono d’accordo. Se la critica negativa della razionalità costituisce una debolezza, è bene accettarla se tutti i risultati della forza della ragione sono quelli che abbiamo sotto gli occhi. Ma la verità è che non si può parlare, se non a torto, in termini di debolezza o di forza del pensiero. Sono solo luoghi comuni di recente invenzione.
Anche nel rischio del viaggio cerchiamo di trovare i rassicuranti elementi del di già dato, vogliamo fare nostra la destinazione, questo è vero, per cui ci qualifichiamo surrettiziamente, ma non vogliamo perderci, come quando partiamo per un viaggio turistico organizzato e lasciamo accuratamente in cassaforte pellicce e ori. Mettiamo qualcosa a repentaglio, ma solo qualcosa, giochiamo una piccola percentuale di quello che possediamo. Ci riserviamo sempre un entroterra di sicurezza. Ecco perché sosteniamo la conoscenza sulla base del metodo dell’ “a poco a poco”. Siamo bottegai e non vogliamo ammetterlo. Sulla soglia della bottega, quando mettiamo fuori il naso, guardiamo sospettosi il cielo e scorgiamo sempre segni di futuri rivolgimenti e, a volte, ci rincuoriamo e sogniamo ad occhi aperti. Poi corriamo subito a rifare l’inventario per paura di avere perso qualcosa. In questo modo, non possiamo pretendere nulla dalla vita, né possiamo darci una prospettiva di trasformazione. Deludiamo gli altri, che prima o poi scoprono il nostro maldestro gioco delle tre carte, e deludiamo noi stessi che, comunque, non potevamo mai sognare di illudere. Così perdiamo ogni contatto reale col mondo che ci circonda, e viviamo contagiati dalla nebbia. Invece di giocare veniamo giocati. La paura rileva sempre la nostra ripugnanza di fronte all’imprevisto e alla diversità.
In definitiva possiamo scappare dalla realtà in due modi, o rallentando la nostra vita, rinchiudendoci nei ritmi del di già conosciuto, o accelerando tutto al massimo, trasferendoci in una crescita esponenziale che volendo abolire la distanza la riconferma nella sua espressione più terribile, quella del carcere, in primo luogo del carcere delle idee.
I due aspetti sono complementari. Non si sfugge ad essi né inseguendo record di velocità, né sognando passeggiate con la carrozza a cavalli.
Alfredo M. Bonanno