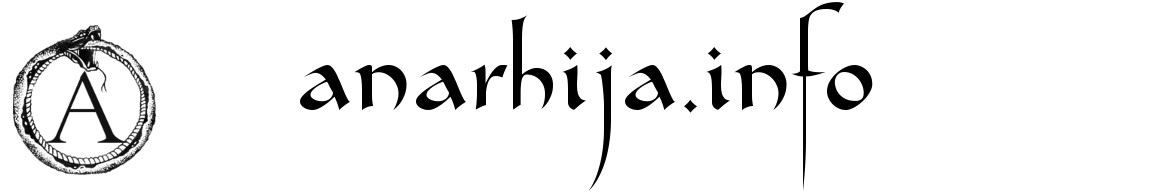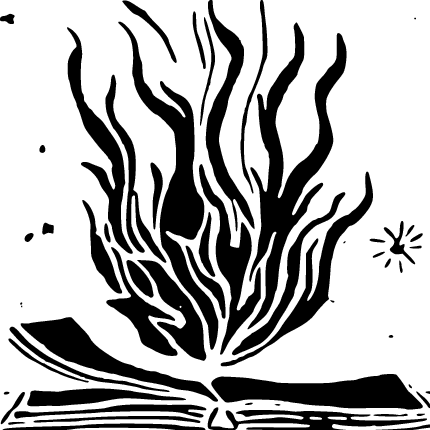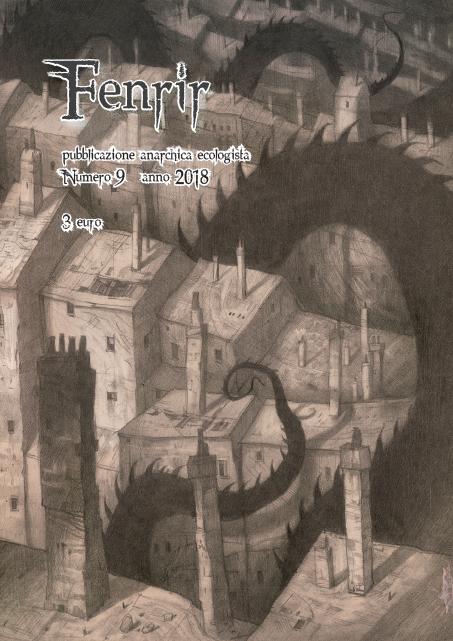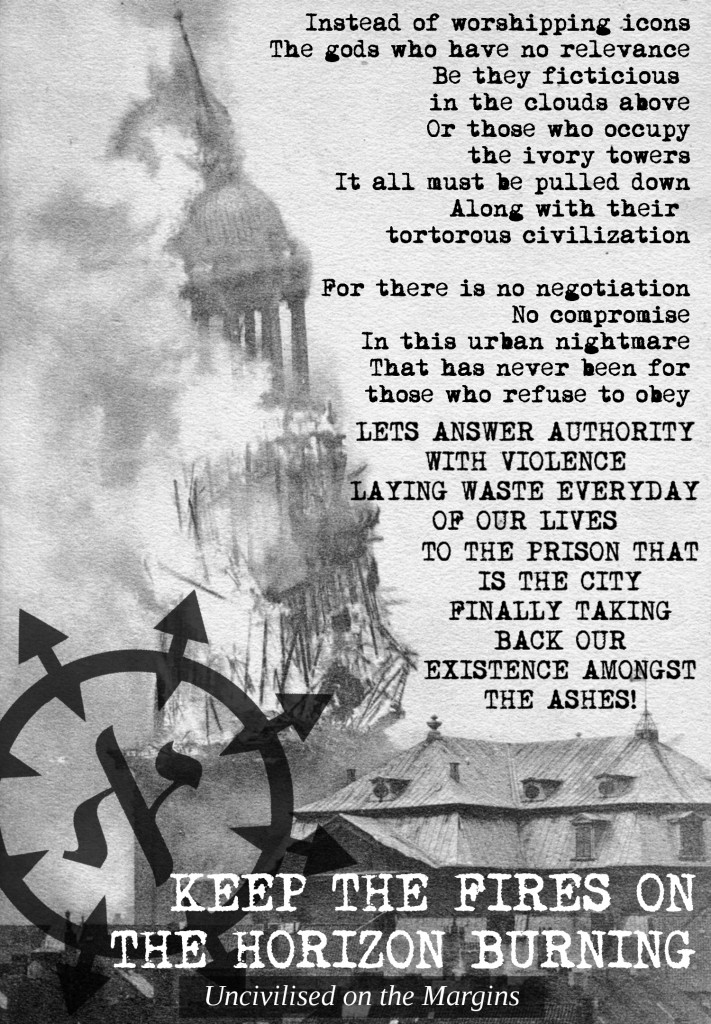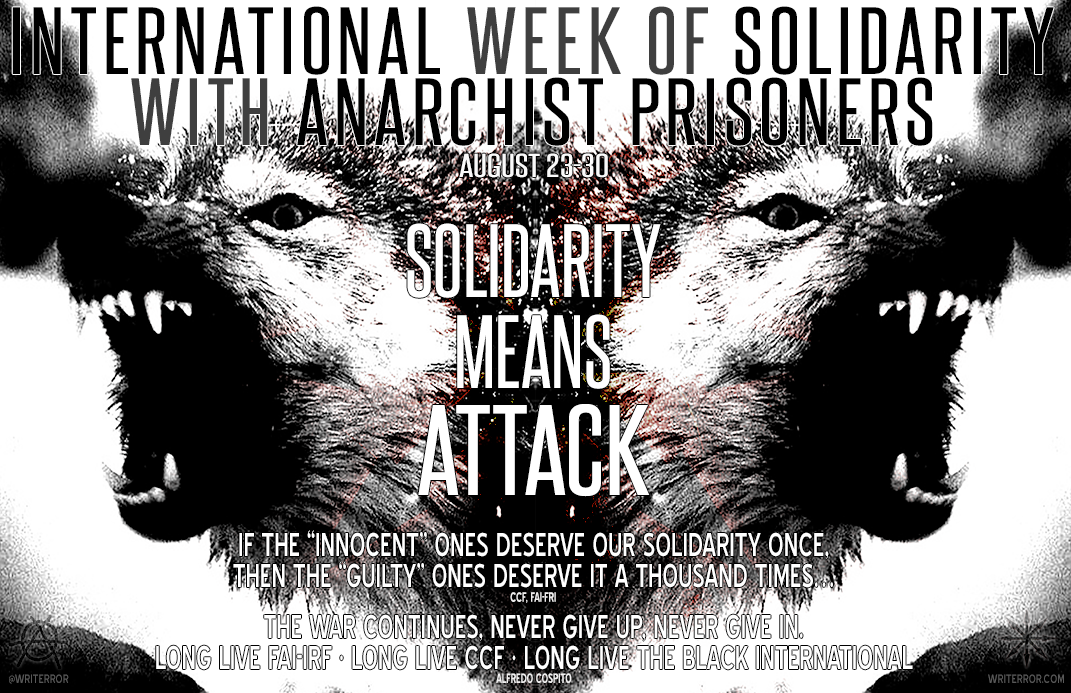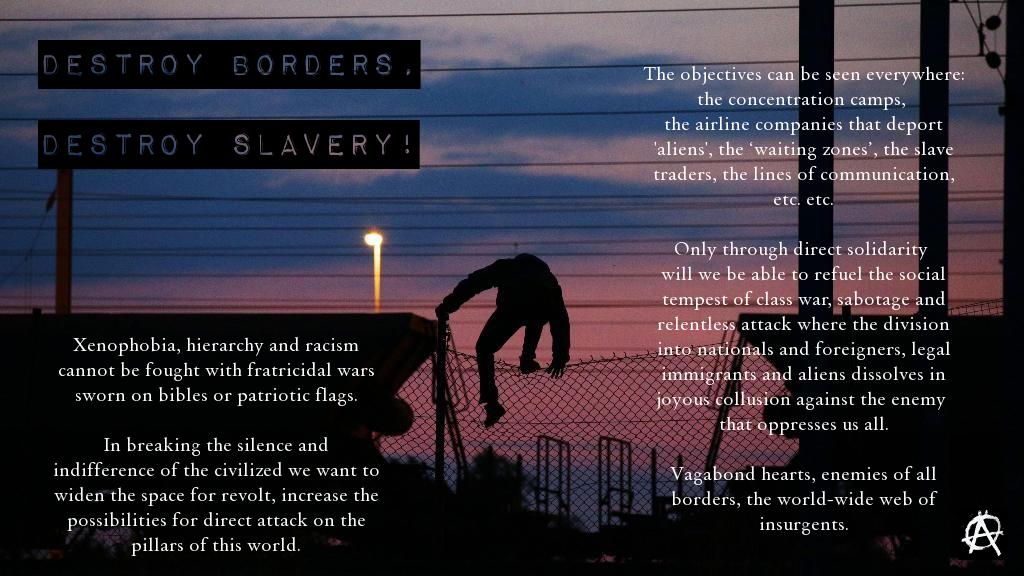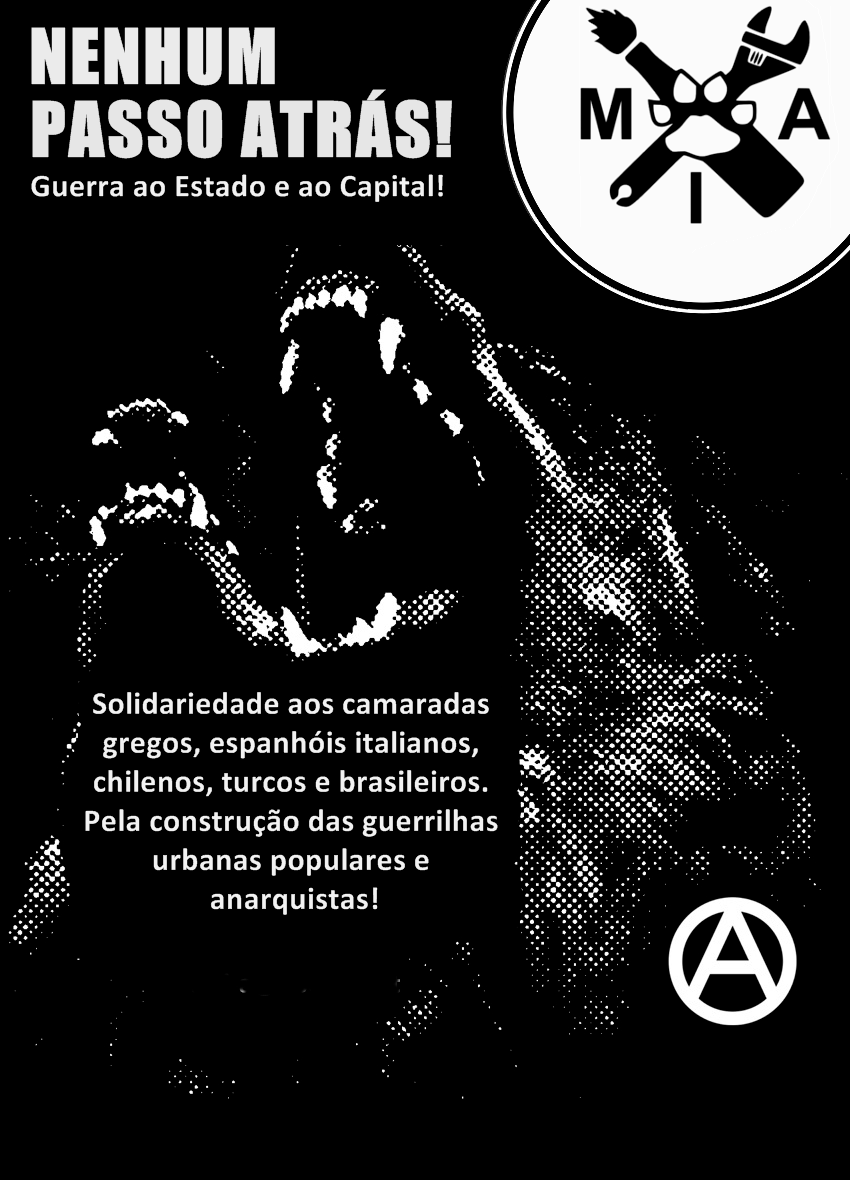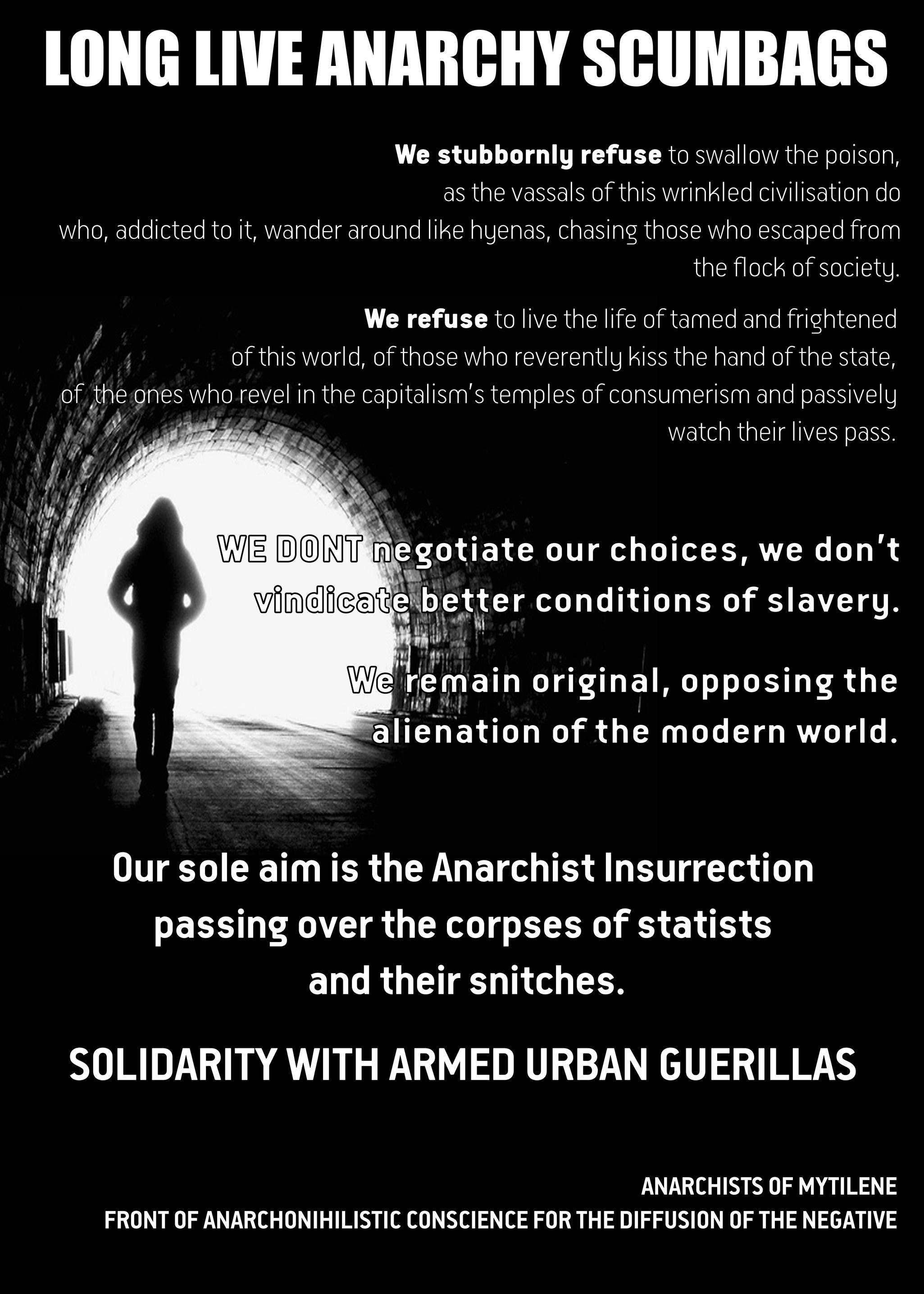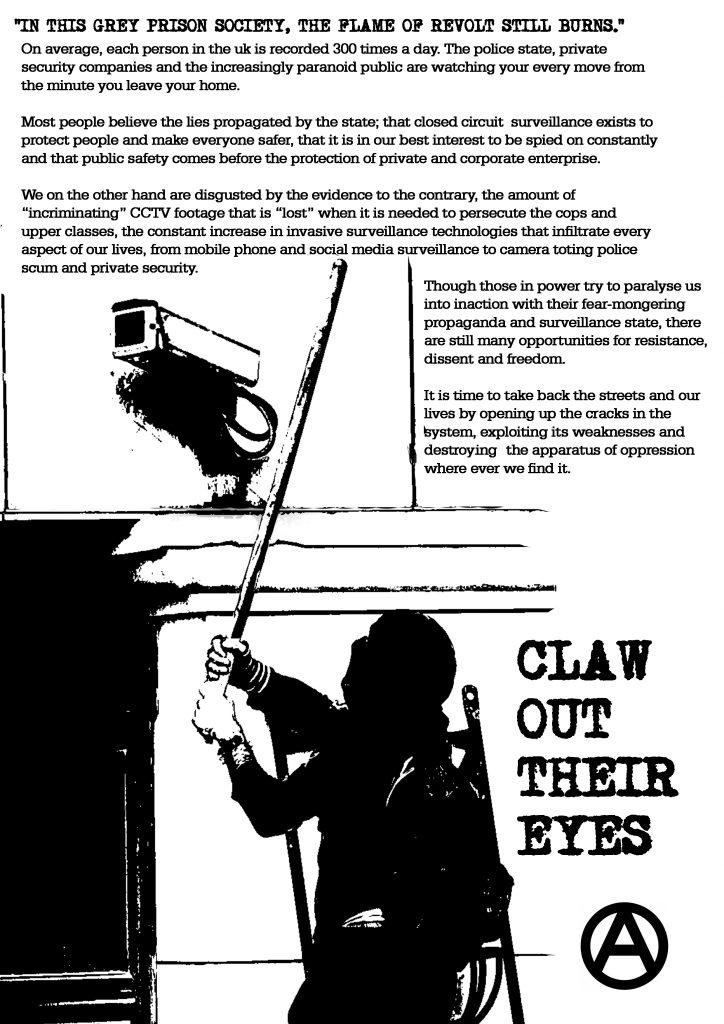«La Natura, c’est moi»
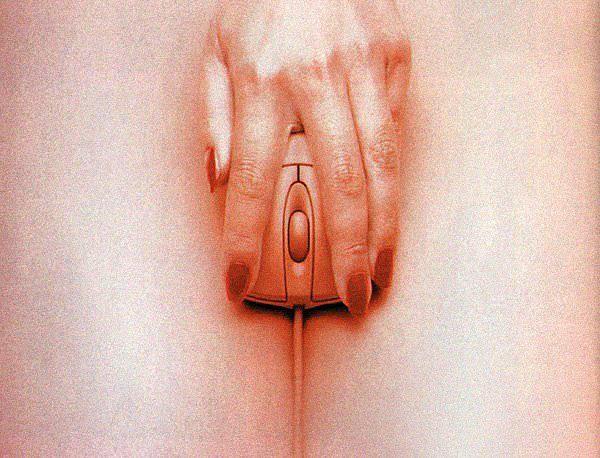
La vita: un’invenzione in vendita
Nessuna distinzione dell’angoscia
Nulla di cui preoccuparsi
Nella sua storia l’umanità non si è mai trovata impreparata come oggi. In poco più di una generazione il nostro concetto di vita e il significato dell’esistenza saranno radicalmente modificati. Di fronte ai nostri occhi si estende un paesaggio ancora sconosciuto i cui contorni stanno per prendere forma nelle centinaia di laboratori di biotecnologia delle università, delle agenzie governative e delle industrie di tutto il mondo. Se il XX secolo è stato caratterizzato dalle scoperte della fisica e della chimica, il XXI sarà infatti profondamente condizionato dalle cosiddette «scienze della vita».
Paradossalmente si potrebbe dire che il XXI secolo sia iniziato in realtà quel mattino di febbraio del 1997, quando i bollettini d’informazione rivelarono agli abitanti di tutta la Terra il segno inaudito apparso nel loro cielo per dominare la nuova epoca, che si apriva all’insegna di una pecora clonata di nome Dolly, nata da un processo di replicazione invece che dal concepimento. E, benché la cosa non offrisse nulla di particolarmente sensazionale, riassumendosi nella foto di una banalissima pecora, le comunicazioni di massa hanno dovuto impegnarsi in una intensiva volgarizzazione per iniziare i consumatori ai misteri della biologia molecolare e della transgenica animale, insegnando loro come questa prima riproduzione non sessuata di un mammifero aprisse alla farmacologia una nuova era. Dopo il computer e la rete universale, oggi è sulle biotecnologie che devono istruirci al fine di farcele apprezzare.
I primi giorni di questa pubblicità bruciante sono stati consacrati soprattutto ad allarmarci circa l’incredibile pericolo che farebbe pesare sull’umanità la possibilità della clonazione umana: solo una barriera etica mondializzata ci proteggerebbe da questa pratica considerata inaccettabile. Dopo una rapida ricaduta, questa febbre di indignazione morale che reclama la proibizione assoluta e solenne di una manipolazione così lesiva della nostra dignità naturale, ha lasciato il posto a vedute più pragmatiche: sarebbe oscurantista e contrario alla nostra vocazione antropologica di scoprire i segreti della “natura” rifiutare lo sviluppo di tecnologie tanto promettenti, indispensabili per studiare i meccanismi fondamentali della vita e della sua riproduzione, senza parlare della possibilità di procurarci organi di ricambio e magari domani di ripulire dei suoi difetti il nostro “programma genetico”. Insomma, l’ingegneria genetica ci viene presentata non come una sinistra possibilità, ma come un dono sociale ed economico.
Del resto ci è stato certificato che non c’è da preoccuparsi, che è assolutamente indispensabile contribuire ai bisogni della ricerca e dell’industria; che agli occhi della macchina sociale ognuno di noi è talmente prezioso che si tratta solo di facilitarci la vita, di renderla più felice; che questo processo di partenogenesi permetterebbe, tra mille esempi, di guardare nel proprio futuro biologico conoscendo nei dettagli il proprio corredo genetico, di produrre in serie ratti modificati per aggiungere alle loro urine rare molecole che curano malattie sempre più sofisticate, o di perpetuare indefinitamente la nostra cagna preferita. Tutto questo mescolato ad argomenti di un umanesimo un po’ vago e ad assicurazioni pronunciate distrattamente, come se si facesse conversazione con qualcuno che ormai non è più in grado di notare la differenza tra cure palliative e guarigione effettiva.
Il tempo passa in fretta, e nel volgere di due anni il consenso si è stabilizzato attorno alla posizione che fu fin dall’inizio degli apologeti più lucidi. Nel frattempo abbiamo comunque fatto una istruttiva scoperta: che l’idea di ciò che potrebbe essere la vita umana è già così perduta, così dimenticata, così rovinata e ormai poco immaginabile che si è oramai incapaci di elaborare una seria argomentazione in grado di contraddire la duplicazione dell’uomo in laboratorio. La manipolazione genetica finisce coll’abbattere le barriere naturali che erano rimaste fino a un dato momento a baluardo contro l’espansione industriale. Ma quella che viene conosciuta in laboratorio non è che la “vita” in laboratorio, vale a dire niente: un “meccano genetico”, una costruzione arbitraria che potrebbe diventare osservabile come forma di vita solo se ricollocata nella natura. Ecco che l’ottusità confina con la stupidità in coloro che reclamano vigilanza, garanzie, in breve un affidamento al vecchio metodo sperimentale. Il mondo “trascurato”, lasciato da parte dal metodo sperimentale, diventa in realtà l’oggetto dell’esperimento continuando però ad essere ignorato.
La vita: un’invenzione in vendita
Ma cominciamo dal principio. Brevemente possiamo definire le biotecnologie come un agglomerato di tecniche mirante allo sfruttamento industriale di microrganismi, cellule animali, cellule vegetali e loro costituenti; tecniche incentrate soprattutto sulla manipolazione e la trasformazione dei geni, in particolare a partire dalla formidabile scoperta — che risale al 1973 — del Dna ricombinante, la cui importanza è data dalla possibilità di ricombinare frammenti di organismi non correlati fra loro, cioè che non si accoppiano in natura, giungendo all’abbattimento degli ostacoli naturali esistenti tra specie e specie. Le biotecnologie interessano settori produttivi che vanno dall’agricoltura alla farmaceutica, passando per la chimica, in un insieme tecnologico in cui “interagiscono” anche informatica, robotica e telecomunicazioni. La produzione di organismi, piante e animali transgenici, come pure di vaccini e test diagnostici medici, costituisce solo un piccolo esempio del prossimo e non troppo lontano futuro che ci attende. Una parte sostanziale della ricerca è concentrata sulla fusione di attività agricole e farmaceutiche, e sulla trasformazione di animali domestici in officine per la produzione di medicinali; mentre clonazione e manipolazioni genetiche consentiranno tra non molto di ottenere animali standardizzati, studiati sia in funzione del consumo alimentare che della produzione di organi destinati ai trapianti esogeni (xenotrapianti).
Le scienze della “vita” avranno via via impensabili applicazioni in qualsiasi settore — in terra, cielo e mare —, persino nella fabbricazione di materie plastiche, nell’estrazione mineraria e, naturalmente, in campo militare. A questo proposito qualcuno ha storto il naso notando che le biotecnologie sono suscettibili di applicazioni indifferentemente “civili” e “militari”, come qualsiasi altra tecnologia. Rilevare questa ambivalenza porta logicamente a riconoscere in tutte queste tecniche delle armi offensive: nessuna novità, si tratta di una guerra contro la vita condotta dal capitale da oltre due secoli. D’altra parte le “conquiste” ottenute dalle tecnologie di ingegneria genetica hanno rinnovato l’interesse militare per le armi biologiche, generando una grande preoccupazione riguardo l’accidentale o volontaria liberazione di pericolosi virus, batteri e funghi manipolati in grado di diffondere un inquinamento genetico in tutto il mondo. Così come è avvenuto per il nucleare, infatti, la banca dati che si è sviluppata per l’ingegneria genetica commerciale nel campo dell’agricoltura, dell’allevamento degli animali e della medicina è potenzialmente convertibile nello sviluppo di una vasta serie di nuovi agenti patogeni che possono aggredire qualsiasi cosa. Per questo vari settori delle forze armate da tempo lavorano con i maggiori agenti patogeni al mondo, dalle malattie esotiche virali ai virus più recenti come l’Aids; mentre nell’immediato l’esercito americano sta inserendo nei batteri geni artificiali simili a quelli usati dai ragni tessitori per produrre il loro filo, una tra le più robuste fibre naturali esistenti: la sua utilizzazione futura potrebbe interessare l’ingegneria aerospaziale o la costruzione di oggetti come i giubbotti antiproiettile. Se in più consideriamo che, a differenza delle tecnologie nucleari, l’ingegneria genetica può essere prodotta a buon mercato, richiede una minore abilità scientifica e può essere usata per un’ampia varietà di scopi militari — dalle operazioni controinsurrezionali fino a guerre su larga scala per distruggere intere popolazioni —, come stupirsi che in un rapporto del maggio 1986 il dipartimento americano della difesa abbia sottolineato che le varie tecniche di ingegneria genetica stanno “definitivamente rendendo la guerra biologica una reale alternativa militare”.
Si comprende meglio l’interesse frenetico di multinazionali, scienziati e uomini di Stato, desiderosi di rivestire un ruolo da protagonisti nella programmazione della rivoluzione biotecnologica. Dal 1988 è partito il Progetto Genoma Umano, programma sponsorizzato dal governo americano con una somma pari a tre miliardi di dollari, ideato al fine di mappare e sequenziare l’intero patrimonio genetico della nostra specie, composto da circa 100.000 geni, entro l’anno 2002. Nel volgere di pochissimo tempo, forse meno di dieci anni, tutti questi geni — le nuove “materie prime” del secolo a venire — saranno sottoposti a brevetto, diventando esclusiva “proprietà intellettuale” di un ristretto numero di aziende del complesso genetico-industriale e di governi (qualche anno fa il governo degli Stati Uniti presentò richieste di brevetto in Europa e negli Stati Uniti per alcune linee cellulari prelevate da cittadini delle isole Solomon e della Papua Nuova Guinea!), i quali potrebbero ottenere analoghi brevetti per microrganismi, piante e animali, conquistando col tempo un potere senza precedenti sulle nostre vite e soprattutto su quelle delle generazioni non ancora nate, attraverso la manipolazione preventiva di tutti i processi biologici del pianeta. Fra le più importanti società multinazionali che stanno conquistando grosse fette del mercato bioindustriale globale non si possono non menzionare: la Monsanto Corporation (che ha acquisito la Holden’s Foundation Seeds, una buona quota della DeKalb, la Asgrow, la Agracetus e la Calgene), la Novartis (che nasce dalla fusione di due società svizzere: l’agrochimica Ciba-Geigy e la farmaceutica Sandoz, che a sua volta nel 1995 ha acquisito la Genetic Therapy Inc.), la Du Pont (che ha acquisito la Protein Technologies International dalla Ralston Purina, oltre ad aver acquistato una buona quota della Pioneer-Hi Bred, l’industria di sementi più grande del mondo), la Dow Elanco (che ha acquistato una grossa quota della Microgen), la Upjohn (che ha investito nella Incyte), l’Eli Lilly (che ha partecipato a un accordo con la farmaceutica Millennium e intrattiene relazioni commerciali con la Myriad Inc. insieme alla Novartis), la Rohm e Haas, la AgrEvo (che nel 1996 ha acquistato la Plant Genetic Systems) e la Schering Plough (che nel 1996 ha acquisito la Canji). Ebbene, tra tutte le società chimiche, farmaceutiche, agroalimentari e biotecnologiche esistenti, è in corso una feroce competizione senza precedenti per ottenere brevetti commerciali su geni, organismi e processi di manipolazione.
Ovviamente il problema dei brevetti sulla vita è stato oggetto di aspre polemiche originate da chi avversa la possibilità di impadronirsi di qualsiasi organismo già esistente in natura. Al centro del problema della brevettabilità c’è la questione se geni, cellule, tessuti, organi e interi organismi geneticamente modificati (ogm) siano veramente invenzioni dell’uomo e non semplicemente creazioni della natura «intelligentemente modificate» dagli esseri umani. Così ci ha pensato l’ufficio brevetti e marchi registrati degli Stati Uniti a risolvere una volta per tutte tale problema, dichiarando che l’isolamento e la classificazione delle proprietà e delle funzioni di un gene è sufficiente a fare della scoperta un’invenzione. Detto fatto.
Così che, dopo le enclosure delle terre comuni del XVI secolo, quelle commerciali di parti delle risorse oceaniche, quelle atmosferiche e quelle elettromagnetiche, dal 1971 hanno cominciato ad essere recintate e privatizzate le risorse genetiche del pianeta; ed ora anche le risorse più personali come il corpo umano stanno per subire lo stesso trattamento e sono sul punto di essere ridotte a proprietà commerciali private e distribuite alle istituzioni commerciali e a quelle politiche sotto forma di “proprietà intellettuale”.
I sogghigni del futuro
a causa dell’indignazione morale che in qualcuno ha sollevato la prospettiva della clonazione riproduttiva applicata all’uomo non è difficile da trovare. In se stesso questo procedimento non pone alcun problema particolare rispetto a una banale fecondazione in vitro: dopo tutto il bambino così prodotto avrebbe lo stesso un padre e una madre, e moralmente nulla lo separerebbe da un individuo ottenuto per iniezione di spermatozoi, che è già una forma di clonazione a due — come illustra l’esempio americano di una fecondazione realizzata con spermatozoi prelevati dal cadavere di un uomo all’indomani della sua morte, poi congelati in attesa del risultato della stimolazione ovarica della donna. Ciò che provoca disagio in realtà è la visione fantascientifica di individui standard fabbricati in serie nelle incubatrici di una industria della riproduzione, magari secondo i bisogni di uno Stato totalitario. Finzione tanto più inquietante in quanto è in un certo senso ciò che siamo diventati all’interno delle infrastrutture della società industriale: la nostra esistenza interamente dipendente, artificializzata e parassitaria, i nostri comportamenti standardizzati alla logica interna alle macchine e agli apparecchi di cui bisogna servirsi per qualunque cosa, il nostro cibo senza sapore né odore, i nostri pensieri conformi al flusso di immagini e di slogan che le comunicazioni elettroniche ci iniettano in permanenza e che alimentano il nostro universo mentale.
È la coscienza repressa da questa degenerazione collettiva a far emergere, in alcuni, lo spettro della clonazione umana. Negli altri l’identificazione è già così avanzata, la coscienza di sé talmente spenta, che queste reazioni morali, questi timori riguardo la «integrità dell’uomo», li fanno sogghignare: il clone rappresenta l’avvento dell’«uomo nuovo» di cui essi sono l’avanguardia, e si rallegrano della promessa di vedere presto il proprio opportunismo completamente giustificato dal senso della storia. Per logica conseguenza, ogni rifiuto degli ogm alimentari — del “Frankestein food”, come si divertono a definirlo essi stessi per beffarsi dello sgomento del popolino — non può che rivelare un attaccamento assai sospetto ai valori del passato.
Intanto la propaganda continua a descrivere un avvenire radioso dove la fame sarà debellata ovunque e finalmente si svilupperà un’agricoltura «rispettosa dell’ambiente» e «capace di proteggerci dalle malattie» con piante trasformate in «fabbriche naturali per costruire molecole farmaceutiche», dissolvendo infine lo spettro della clonazione umana e l’ombra di Frankestein, abbandonati come pregiudizi di un’altra epoca, di una vecchia storia lontano da cui ci trascina questa precipitazione degli avvenimenti che costituisce tutta l’attrattiva della vita contemporanea; dove non passa settimana senza che giornali accreditati non pubblichino un bollettino di vittoria sul fronte delle biotecnologie. “Scoperte” tecniche che si susseguono con una successione così rapida da spazzare tutte le resistenze che incontrano sulla propria strada per addentrarsi sempre più all’interno del territorio della vita, impazienti di raggiungerne in fretta gli ultimi confini e di proclamarne l’intera conquista. Finalmente dappertutto alle frontiere del mondo vivente sventola la bandiera della razionalità scientifica. Ma, perché questo ottimismo biotecnologico, omologo a quello cibernetico, resti verosimile, è meglio evitare di leggere le altre pagine dello stesso giornale, dove regna piuttosto un’atmosfera da disastro planetario ad evoluzione non meno precipitosa, da crollo accelerato di tutti gli equilibri climatici, da rovina delle risorse naturali da parte delle forze produttive e da decomposizione interna inesorabile della società mondiale sovrappopolata in preda alle malattie infettive, alla fame, alla sete, all’inquinamento chimico e alle guerre “intelligenti”.
Nessuna distinzione dell’angoscia
Si capisce come mai la società organizzata su scala mondiale viva da tempo in un’atmosfera da stato d’emergenza, che certo riflette il suo stato reale, ma che è anche l’aria da catastrofe in cui deve farci vivere per imporci le sue novità tecniche. Come per le piante geneticamente modificate l’argomento della rapidità del processo di selezione (da 2 a 3 anni invece che da 20 a 30), al di là di soddisfare le necessità del ritorno sull’investimento, corrisponde all’imperativo di abolire ogni possibilità di regresso, di distanza, di semplice tempo di riflessione, così per l’ingegneria genetica applicata all’uomo, la rozzezza meccanicistica delle terapie annunciate (un gene, una malattia), oltre ad essere inscritta nella continuità delle rappresentazioni della medicina scientifica precedente (un microbo, una malattia), mantiene con la sua propaganda sui “cattivi” geni il clima d’angoscia di cui ha bisogno per sbarazzarsi delle conoscenze ragionevoli sull’ambiente morboso e di ciò che un tempo si chiamava eziologia delle malattie. Persino il crimine è stato trasformato in una questione di salute fisica, spostando il dibattito dai fattori ambientali e sociali che potrebbero influenzarlo agli “errori” genetici da controllare od estirpare.
La stessa logica viene applicata nelle promesse di trattamenti miracolosi che — ci dicono — argineranno la progressione finora inesorabile dei tumori, ed è per questo che si comincia a fare pubblicità alla paura che finirà con lo spazzare via ogni reticenza sulle biotecnologie. Perché le biotecnologie non hanno da venderci soltanto i fantasmi della perfezione terapeutica e dell’immortalità attraverso la clonazione. Più prosaicamente, esse hanno già iniziato a imporre nell’agricoltura alcune specie geneticamente “arricchite”; lo spauracchio della clonazione umana potrà servire piuttosto, come mostruosità fantastica, a banalizzare quella ben più reale e tangibile degli organismi manipolati geneticamente.
Ma, se è vero che la continuità esistente tra l’agricoltura industriale e il suo perfezionamento biotecnologico è la stessa che porta naturalmente dalla medicina meccanicistica all’ingegneria genetica applicata all’essere umano, appare estremamente sciocco pretendere di distinguere, come fa un buon numero di oppositori agli ogm, le eventuali applicazioni terapeutiche delle biotecnologie, che si guardano bene dal disapprovare, per non urtare l’opinione generale o perché convinti che si tratti di un auspicabile segno di progresso.
L’alienazione delle persone isolate all’interno della società di massa, che le ha spinte ad abbandonare allo sfruttamento industriale la natura esterna all’uomo — in cambio di un nutrimento standardizzato che ci si cura poco di sapere come venga esattamente prodotto —, è anche quella che ha fatto consegnare loro la propria natura organica, il proprio corpo, all’industria della salute.
Allarmare gli uomini per ciò che accade nei campi, così lontani dalla loro vita artificiale, senza interessarsi a ciò che immediatamente li rassicura (il contenuto del loro armadietto farmaceutico, la chirurgia estetica, le promesse delle terapie genetiche) è illogico e nel contempo vano. Così come è vano spiegare che in realtà quelli che i biologi molecolari indicano come errori da correggere, sono variazioni sul tema di un ricco contenitore di diversità genetiche essenziali per mantenere la variabilità della specie nei riguardi di un ambiente in continuo mutamento. Né ha senso rivelare che queste nuove tecniche transgeniche sono piuttosto primitive se comparate ai processi propri della natura: si tratta di un punto che viene volentieri tralasciato nel clamore creato intorno alle novità dell’ingegneria genetica.
Sì, forse sono in pochi a credere seriamente all’approssimarsi di una simile manna, nonché panacea; ma è sufficiente perché tutto passi nella precipitazione degli avvenimenti, dell’adattamento rassegnato di coloro che, avendo smarrito da qualche parte — tra il cellulare, i neurolettici e il computer — il sentimento della propria integrità, non possono di certo restare scioccati da un pomodoro contenente qualche gene di pesce.
Progressisti e uomini di buona volontà
«Come rifiutare certi straordinari progressi nati nei laboratori della biotecnologia? I nuovi metodi di manipolazione genetica rispondono a tanti dei nostri desideri e aspirazioni…». Così formulata, la questione ha per lo meno il merito di indicare che per molti individui ciò che promettono le biotecnologie è non solo accettabile ma misteriosamente desiderabile. E se proprio bisogna preoccuparsi per qualcosa, sarebbe piuttosto per il fatto che queste promesse potrebbero alla fine non essere mantenute, o mantenute non del tutto.
Ed essendo la buona volontà del progressista decisamente inesauribile, eccolo dunque disposto a vivere con organi e prolungamenti artificiali così come aveva imparato a «vivere col nucleare». L’eterno cliente, in questo rimasto elettore, ha sempre creduto di possedere un parere personale e qualche cosa da scegliere, mentre non è che un organo di ricezione delle decisioni del mercato. Adesso accetta di diventare una specie di mutazione, di trasformarsi in un portaorgani da trapianto per i prodotti innovativi dell’industria medica, acconsentendo di fatto ad essere l’appendice organica, la periferica un po’ ingombrante e sciocca del suo terminale informatico connesso con la rete mondiale. In sintesi, egli ha accettato d’essere diventato una creatura della civiltà industriale, una forma di vita biologica di cui questa ha bisogno per perpetuarsi ed estendersi; e che essa può decidere di correggere geneticamente per meglio adeguarla alla sua funzione, così come l’addomesticamento degli animali migliorava le specie con la selezione dei caratteri che le rendevano inadatte alla vita selvaggia.
E mentre le imprese mondiali della sopravvivenza monopolizzata prospettano il mercato della catastrofe anticipando il momento in cui — essendo la salute e l’agricoltura ugualmente devastate — sulla medicina e sul sostentamento si reggerà l’ultimo racket mercantile, gli entusiasti della rassegnazione si preparano ad «entrare in una nuova era», a completare «una mutazione senza precedenti dalla rivoluzione neolitica», con l’introduzione di impianti e protesi destinati a equipaggiare il nostro sbocciare in un mondo industriale infine realizzato — dalla fabbricazione d’organi con colture guidate di cellule madri alla produzione di feti anencefali che servirebbero da magazzini di tessuti, dagli ormoni di gioventù prescritti dai trent’anni in poi ai “braccialetti elettronici” del carcere fuori delle mura, che basta collegare ai satelliti perché il mondo intero diventi una prigione virtuale sorvegliata da un guardiano orbitale, e tutto il guazzabuglio cibernetico indispensabile alle illusioni della realtà virtuale o agli automatismi della guerra istantanea.
Un mondo senza fuori
Non serve possedere conoscenze particolari di biologia molecolare per poter affermare che le imprese dei tecnici della manipolazione avranno conseguenze incalcolabili, perché incontrollabili e irreversibili. L’essenza qualitativa delle forme di vita manipolate come cose, che rimane incompresa e trascurata, e che si ritiene di poter tranquillamente eliminare per sostituirvi logiche genetiche specifiche, deve necessariamente diventare il fattore decisivo; non essendo la “catastrofe” che il profitto illecito della totalità ignorata.
Tanto più che nessuna contraddizione potrebbe mai spingere il dominio da solo a riflettere su se stesso: quando le invasioni di parassiti, la moltiplicazione delle infezioni, la sterilità delle terre o l’aumento dei tumori gli segnalano un errore manifesto di metodo, invece di tener conto di questi avvertimenti e di modificarlo, cerca piuttosto di distruggere l’avvertimento che lo ha contraddetto, inventando un nuovo insetticida per contenere i parassiti sempre più coriacei selezionati sulla base di quella resistenza, nuovi antibiotici, la coltivazione fuori suolo e terapie favolose per rallentare la progressione delle metastasi. Si capisce come l’artificialità sia diventata ideologia ufficiale del dominio, che nega la necessità e perfino la stessa esistenza della Natura, cercando da sempre di essere una totalità da cui gli uomini non possano immaginare di uscire, un mondo senza fuori. Ed è proprio perché il dominio ha sempre avuto orrore dell’idea che qualcuno possa esistere al di fuori di sé, che deve riscrivere le leggi della natura per renderle conformi alle sue più recenti manipolazioni della vita, cercando di razionalizzare la nuova attività tecnologica ed economica del secolo della biotecnologia come un riflesso dell’ordine naturale delle cose: si tratta solo del “breve passo” di costruire un modello della natura che sia strettamente simile al mondo realizzato dal dominio. Perché ogni società deve sentirsi rassicurata dal fatto che il modo in cui conduce le proprie attività sia compatibile con l’ordine naturale delle cose, rispecchiando il grande disegno della natura: ecco spiegata l’impazienza del dominio di proclamare l’abolizione di quest’ultima a profitto delle sue biotecnologie.
Ottenendo l’accesso alle basi genetiche di ciò che esiste organicamente (come in precedenza a quelle atomiche nell’inorganico), mettendo in luce ciò che c’è di più astratto in noi ed estraneo a noi stessi, stabilendo il nostro codice genetico, che diventa la nostra autentica identità ai suoi occhi, la ragione strumentale finisce per identificarsi totalmente col dominio che l’ha così prodotta, confondendovisi: non si può più pensarli separatamente. Ogni acquiescenza a questo positivismo — a maggior ragione quando questo manifesta maggior premura nei nostri confronti — lo è innanzitutto al dominio e alla nostra stessa alienazione, che fa sempre in modo di dispensarci dal sapere esattamente ciò che facciamo, di averne la piena conoscenza, fornendoci la comodità di non dover essere interamente consapevoli dei nostri atti, di non doverci trovare là di persona. La medicina scientifica ci ha già spossessati delle nostre malattie, di questa conoscenza di sé, rendendocele estranee; col sequenziamento del genoma sarà la nostra stessa vita a diventarci estranea, ma non ce ne accorgeremo. Ecco la felicità. «Per l’individuo, il dominio incarna l’universale, la ragione nella sua realtà», e lo solleva così dalla sua perplessità davanti alle imbarazzanti ricchezze della vita, semplificando quest’ultima a un modo d’uso completo che la metta al riparo del caso e dell’ignoto: ad esempio, i test genetici di predisposizione alle malattie e ai comportamenti trasformano l’esistenza in una fatalità che non intrattiene alcun rapporto con le condizioni sociali. Queste diventeranno impensabili in quanto a determinazione e saranno naturalizzate in dati pratici intangibili, in condizioni di esistenza della collettività al di fuori della quale nulla esiste.
L’individuo è solo con il suo destino genomico; la sua esistenza sociale non è che un riflesso, o una sanzione. Si obbedisce perché si è sprovvisti dei geni del potere.
L’improponibile precauzione
La critica razionalista del riduzionismo genetico si presenta dunque abbastanza debole, nel denunciare una grossolana menzogna ideologica sulla natura umana senza arrivare a riconoscere che questa menzogna è, sotto i nostri occhi, sul punto di appropriarsi della realtà, di fare sparire ciò che la smentirebbe e diventare così “vera”. La superstizione scientista nella società di massa avrebbe qualcosa di incomprensibile, dato lo stato in cui questa scienza ha messo il mondo, se non ci fosse a sostenerla, oltre che una certa viltà nel lasciarsi trascinare di speranza in speranza, contro ogni evidenza, l’aspirazione apparentemente generale a condividere questo privilegio riconosciuto degli scienziati: non dover pensare, essere sollevati da questo fardello e grazie a ciò essere tanto più adatti alle specificità della società delle macchine. Chi concepisce se stesso per mezzo delle rappresentazioni della cibernetica si trova fortemente spiazzato di fronte alle attività dell’ingegneria genetica: quale natura umana gli resta da invocare? Se si osserva un giovane consumatore di dodici anni assorbito dalla sua PlayStation e si immagina il destino assegnatogli nella civiltà elettronica, non si vede quale obiezione verosimile potrebbe ancora essere fatta alle clonazioni e alle manipolazioni genetiche: il risultato è già davanti a noi, con i suoi abiti di marca e il suo piercing, la sua cultura flessibile, il suo linguaggio ridotto e il suo tatuaggio. Forse è un po’ tardi per preoccuparci di ciò che resterà di noi dopo la ricostruzione genetica, e d’altronde nessuno ci fa caso seriamente.
Molte associazioni che si oppongono alla disseminazione degli ogm — che mostrano i rischi dei guasti forse irreparabili nell’”ecosistema”, insistono sulla necessità di avere garanzie e sicurezze, parlano di «gestione accorta delle risorse» chiedendo moratorie sulle coltivazioni e accompagnano la loro invocazione al “principio precauzionale” con la rituale esortazione a prendersi cura dell’avvenire — non sono convincenti. Non soltanto perché parlano di cautela, di regolamentazione, di esperimenti — quando già nel 1998 svariate coltivazioni geneticamente modificate si estendevano nel mondo su una trentina di milioni d’ettari di terreno —, ma soprattutto perché l’efficacia della propaganda poggia sul fatto che, essendo diventato impensabile l’avvenire, gli scenari della transgenica non si distinguono nemmeno più da una assurdità particolare. Il salto nell’ignoto tutti sentono che bisogna comunque farlo, e se la questione è «Come nutrire sette, otto, nove, dieci miliardi di uomini?», la risposta può ben essere la transgenica. Certo la falsa coscienza media, debitamente informata, ammetterà che l’innocuità delle biotecnologie non è assicurata; ma come può pesare questa incertezza quando tanti altri fenomeni inquietanti premono già attorno a noi, dalla sregolatezza climatica alla precarietà dell’approvvigionamento dell’acqua, per scoraggiare la riflessione e ogni genere di intervento contro gli imperativi tecnici e le consegne del dominio.
Attendere di poter constatare gli effetti delle biotecnologie per giudicarle significa trascurare, tra le altre cose, che siamo proprio noi le cavie di quegli esperimenti. Significa soprattutto rifiutare di pensare a quel che abbiamo sotto gli occhi, non volerne vedere la mostruosità. In effetti, e senza nemmeno dover esaminare gli organismi chimerici elaborati in laboratorio, sappiamo che la transgenica genera mostri, nel senso stretto, specie di nuovi esseri che esistono ma che non si possono classificare, che non appartengono a nessuna categoria conosciuta: animali acefali, supertopi dotati del gene di fabbricazione dell’ormone della crescita umana, caprepecore, piante di tabacco che producono l’emoglobina umana, piante di mostarda trasformate in fabbriche di materie plastiche, agrumi creati da colture di tessuti, e così via.
Ma la mostruosità dei risultati non fa che palesare quella della concezione stessa che mira a distruggere le categorie, la nozione stessa di specie in quanto entità distinte e identificabili, e a trattare ogni specie particolare “come una banca di geni potenzialmente trasferibili” rimuovendo i confini naturali con le altre specie.
Per non distinguersi più
Stabilire dunque una distinzione tra le biotecnologie significa rifiutare di vedere che è la stessa potenza di disintegrazione a danneggiare tutte le forme di vita, siano piante, animali o uomini, trattati come un unico materiale genetico indifferenziato. Le biotecnologie dissolvono tutte le distinzioni, tutta la sorprendente varietà dei fenomeni che la natura aveva posto nei suoi regni organici e, al loro interno, tra le specie. Esse non vedono che un brulichio di figure cangianti azionate dall’interno da geni codifica(n)ti che sono la realtà comune di tutti i fenomeni viventi; microprocessori biochimici ricombinabili a volontà e all’infinito per confezionare altri fenomeni, inediti, più utili, più comodi e specifici. La tautologia della razionalità tecnica ricopre tutta l’estensione della vita: le macchine che permettono di realizzare il sequenziamento del genoma sono anche quelle che forniscono il modello teorico della “informazione genetica”. Il codice genetico è esattamente una creazione dell’era dei computer, e la straordinaria povertà di questa ideologia del Dna, che si direbbe uscita armata di tutto punto dal cervello degli informatici, esprime fedelmente quella del loro formalismo logico. Ma questa miseria non ha proprio nulla di straordinario né di particolarmente scioccante in una società che inizia a plasmare fin dall’asilo il cervello dei bambini abituandolo al computer, che sarà contemporaneamente il loro strumento di lavoro, il loro mezzo di contatto con il mondo esterno e la loro effettiva dimora. Una società in cui il progetto di un computer che obbedirebbe al pensiero grazie a un impianto nel cervello dell’utilizzatore non provoca alcuno stupore è una società che risponde in anticipo alla questione di sapere quale margine di autonomia debba essere lasciato al pensiero umano, alla coscienza, la cui scomparsa è proprio ciò che permette di intravedere tale miglioramento del rapporto uomo-macchina.
Ciascuno non è ormai che un esemplare intercambiabile di cui gli amministratori dell’esistente non hanno alcun bisogno particolare e di cui niente può giustificare l’esistenza, nemmeno ai loro stessi occhi. La società di massa ci aveva già efficacemente condizionati a percepirci come esemplari duplicabili di una specie: così entriamo senza troppo turbamento nell’era della nostra riproducibilità tecnica (che, ancora una volta, non ha bisogno di essere effettivamente generalizzata per rendere vetuste le antiche concezioni di vita). L’”io” inorganico della psicologia comportamentale — l’uomo plasmato dalla merce e dai suoi rapporti sociali — non può trovare nulla da obiettare alla propria dissoluzione nella programmazione neurochimica dei geni codificanti. Di fatto, non solo gli sembra di non perdere granché, bensì di ottenere un sentimento di sicurezza, l’assicurazione di essere con ciò meglio integrato nel funzionamento generale delle macchine, e dunque della collettività sociale, da non potersi ben presto nemmeno più distinguere. I deliri dei “cyborg” e altre fantasie flessibili dell’avanguardia tecnofila all’americana esprimono senza inibizioni né censura un desiderio fra i più diffusi nella nostra atmosfera da catastrofe: essere protetti attraverso la propria assimilazione, il proprio mimetismo intimo con le macchine del dominio impersonale.
Nell’era della biotecnologia, le specie separate con nomi separati stanno cedendo gradualmente il passo a sistemi di informazione che possono venire riprogrammati in un numero infinito di combinazioni biologiche. Perché è molto più facile per la mente umana accettare l’idea di programmare un sistema di informazioni che accettare l’idea di programmare un cane, uno scimpanzé o un essere umano. L’idea di una natura umana inalterabile, che potrebbe opporsi al progetto della nostra riprogrammazione biologica come una forza vitale indipendente dalle mediazioni tecniche, di cui basterebbe riappropriarsi, è d’altra parte corrosa da troppo tempo dalle alterazioni che gli elementi tossici della società industriale provocano nel nostro organismo: ci diventa impossibile riconoscere la nostra integrità nel nostro corpo, quando malattie, sindromi, squilibri dai percorsi misteriosi e dalle cause definitivamente inafferrabili ce la alienano. La minaccia delle malattie moderne (cancri di tutti i tipi, ma anche virus mutanti, e così via) gioca per lo sviluppo dell’industria della manipolazione genetica lo stesso ruolo di giustificazione che la minaccia nazista aveva giocato per la messa a punto dell’armamento atomico da parte della megamacchina “democratica”.
Persino gli oppositori agli ogm rifiutano in genere di affrontare questi fatti, piuttosto scoraggianti, non avendo in realtà nessun’altra concezione della vita da opporre a quella della ragione economica e rimproverando al dominio soprattutto di non essere abbastanza scientifico. Ma non è il «pensare all’avvenire», è il pensare in sé che si trova socialmente colpito da paralisi, come dimostrano disgraziatamente codesti oppositori che, pur di essere considerate persone “responsabili”, sospendono il proprio giudizio sulle biotecnologie dichiarando in anticipo di accettarne gli aspetti medici “buoni”, e limitandosi a reclamare un ampio dibattito pubblico e democratico sull’argomento.
Un’impeccabile felicità
Come stupirsi che una società che manifesta attraverso tanti comitati etici il proprio sgomento sulla materia incontri tante difficoltà a tracciare una frontiera oltre la quale ci sarebbe incontestabilmente un “oltraggio degradante” alla condizione umana. Interrogarsi sulla “dignità umana” di un embrione congelato è a dir poco spassoso, se si considera che all’inizio per produrre tutto ciò la dignità era stata bellamente trasformata in una nozione fra le più astratte (e l’umanità altrettanto). L’indegnità dell’embrione congelato e immagazzinato in attesa di un “nuovo progetto familiare”, è il risultato di quella dei suoi “genitori”. La procreazione sempre più tecnicizzata, per produrre la merce umana con migliori garanzie, ha logicamente fatto ricorso a tutto ciò che potrebbe assicurare “zero-errori”. Infine il passaggio alla coltura di cellule madri embrionali prepara ora queste “terapie germinali”, che delle terapie hanno solo il nome, trattandosi di fatto di modificazioni trasmissibili, di eugenetica positiva. Così che al traguardo, quando più nessuno saprà di preciso cosa si potrebbe opporre alla clonazione degli embrioni, oggi così “oggettivamente” necessaria, si sarà costretti a constatare che tutti questi progressi dell’eugenetica razionale si sono susseguiti secondo una logica dal rigore inflessibile, alla quale del resto né i tecnici della procreazione medicalizzata né i suoi “utenti” si sono curati di resistere, aspirando anzi gli uni come gli altri a spingerla “più lontano”.
In modo ancora più marcato di quello che era stato il caso dell’antica eugenetica (nazista ma anche americana o svedese), i tecnici della biologia si mostrano in qualche maniera socialmente predestinati a sviluppare, senza scrupoli né cinismo ma in tutta buona fede, questa ideologia dei geni “buoni” e “cattivi”. Ora, che la società capitalista definisca “buono” ciò che facilita la sua perpetuazione, essi sono certo pagati per saperlo, ma vanno anche oltre. Seguono con tanta fiducia le regole dell’efficacia funzionale, e i loro interessi si sono così naturalmente sedimentati nel loro “pensiero” diventato semplice funzione del processo di produzione, che in tutta spontaneità e anche con le migliori intenzioni del mondo essi vedono nei comportamenti “anormali” — soprattutto socialmente — semplici disfunzioni biologiche che si possono e si devono correggere per mezzo di interventi chimici e oggi genetici. Quando qualcuno domanda: «Se si hanno i mezzi per migliorare gli uomini, perché non farlo?» esprime una concezione secondo cui sono gli uomini ad essere “cattivi”, inadeguati, non all’altezza, rispetto all’impeccabile razionalità del sistema e a quella dei modelli di adattamento che sono i ricercatori stessi. Dal canto loro, i genitori per cui, in un ambiente sociale di competizione sempre più duro, la produzione di un bambino rappresenta un investimento finanziario sempre più elevato, sono tanto più portati ad accordare fiducia alla “scoperta”, pubblicizzata dai media, del gene della schizofrenia, della depressione, dell’alcolismo, della nevrosi, dell’adulterio, dell’omosessualità, dell’aggressività, eccetera. Scoperte false, abusive, assurde ma la cui pubblicità permette di diffondere, sul modello delle malattie ereditarie, l’idea di una determinazione genetica delle prestazioni sociali, e di giustificare così, oltre alla presa in carico medica fin dalla gestazione, i test genetici che perfezionano la reificazione completa dei bambini in oggetti di soddisfazione dei loro genitori, in prodotti da “ottimizzare”, con successivamente tutti i complementi alimentari, i trattamenti chimici, le logiche d’apprendimento.
«Se un individuo superiore, e presumibilmente il suo genotipo, è identificato, perché non copiarlo direttamente piuttosto che andare incontro a tutti i rischi, inclusi quelli della determinazione del sesso, coinvolti nella confusione della ricombinazione (la procreazione sessuale)? Si lasci la riproduzione sessuale per scopi sperimentali: quando si trova un tipo adatto bisogna essere sicuri di mantenerlo per mezzo della moltiplicazione dei cloni» — dr Joshua Lederberg
Niente da tramandare
Rinchiusi nei loro laboratori bioinformatici, i profeti del Dna ricombinante promettono di «rifare l’Eden» moltiplicando le nuove specie; paradiso che accoglierà i nostri successori evolutivi, frutto dei loro lavori.
Ma non è soltanto per il progresso della medicina scientifica che gli uomini non si rassegnano più a morire, è soprattutto perché hanno la certezza di essere dimenticati in fretta, di non lasciare nulla dietro di sé, per non avere trasmesso niente, per non scorgere attorno a sé nessun discendente intelligibile, per essere stati nel corso della loro esistenza nient’altro che pezzi staccati completamente intercambiabili all’interno di una macchina sociale che non conserverà alcun ricordo del loro passaggio. Se ormai vivere significa essere niente, morire è non essere mai stati. Questa triste evidenza, a cui è difficile rassegnarsi, è una delle principali determinazioni dei soggetti moderni e della loro tendenza depressiva; che fa accettare, sulla promessa di qualche anno supplementare «in piena forma», che tutta la vita trascorra in una totale dipendenza dalla società organizzata in cui ci troviamo rinchiusi. In altri tempi si lasciava il proprio corpo alla scienza; ora le apparteniamo da vivi, proprio come un cadavere, ancor prima che ci smembri nei suoi ospedali.
[Diavolo in corpo, n. 1, dicembre 1999]